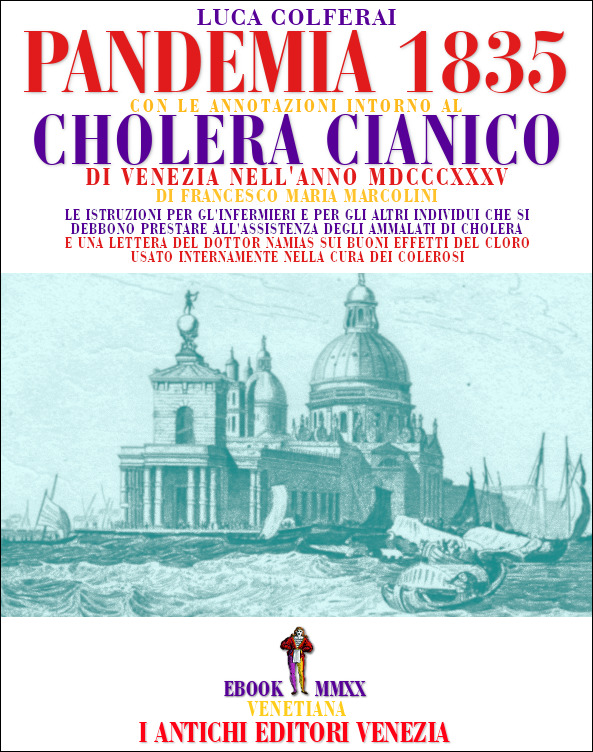Naufragio in Canale della Giudecca
E d’improvviso il garbin. Ma fisso. Il canale della Giudecca, che già ribolliva di onde sotto la sferza implacabile di centinaia di barchini, motoscafi, ferry boat, topi battelli e peate, s’imbizzarrisce completamente. Onde di qua e di là, di su e di giù. La sampierota ondeggia, beccheggia, rolla, sussulta, s’impenna, s’inabissa. Spruzzi d’acqua e scorze d’arance, bottiglie di varechina e cespi d’insalata, sacchetti dei supermercati un cappello di paglia da donna ammuffito volano da tutte le parti mentre cerco disperatamente di mantenere la rotta. L’acqua sparisce da sotto l’elica e il motore fa un rumore come un leone catarroso ma molto incazzato, ogni volta che manca la presa. La mia morosa, che peserà sì e no cinquanta chili, è sballottata di qua e di là e mi guarda molto storto come se fosse molta colpa mia.
Dalle banchine del porto, lì in fondo, si alza un suono terribile da drago che si risveglia furiosamente contrariato e un’ombra gigantesca immane si staglia contro il cielo, muovendosi lenta e circospetta come il destino implacabile e infallibile quando si avvicina alla sua vittima inerme. È lì, a una quarto della traversata del canale della Giudecca, in un ventoso pomeriggio di giugno di qualche anno fa, che capisco quanto fragile e instabile sia la vita umana.
Siccome sono veneziano. Ho comprato una sampierota. Ad essere sinceri fino in fondo sono nato a Venezia, in campo Sant’Aponal. Poi mi hanno mandato in esilio al Lido. All’età di quattro anni. Il confino, che è durato fino all’estate scorsa, ha comportato un mutamento sostanziale delle mie attitudini. Gli abitanti dell’isola litoranea, infatti, prediligono l’automobile, i motorini, le motociclette, gli aerei. Insomma: qualsiasi mezzo di trasporto purché moderno grosso e dotato di ruote, anche pedalò e aquascooter. Ma dodici anni fa ho acquistato Manisse. Per dispetto, penso.
Manisse è il nome della mia sampierota, lunghezza metri sei virgola settantacinque, adesso motore nipponico susuchi sie cavai, al tempo degli accadimenti qui raccontati però un albionico giònson settecavalli, serbatoio forcole remi mezo mariner e salvagenti inclusi. Manisse, che prima era anonima, ha una particolarità unica e rientra nel novero di quelle cose che oltre a non avere uguali non sono nemmeno riproducibili; come si dice «i gà perso el stampo». Essa è, a quanto io sappia, l’unica sampierota in vetroresina della laguna. Nel suo caso sarebbe meglio dire: «i lo gà butà via». El stampo.
Queste cose devo scriverle piano, sennò mi sente e si ribella. Comunque è molto carina e appena pitturata, pulita e lustrata, fa la sua bella figura. «Un figuròn» si direbbe. Ma il suo essere di plastica, e non più molto giovane, fa sì che sia piuttosto bizzarra, riottosa e decisamente ingovernabile: è vero che adesso ci sono tantissime imbarcazioni tipiche lagunari in vetroresina, ma trent’anni fa era decisamente un modello sperimentale.
Intanto, l’immane sagoma che si era staccata dal molo ululando incombeva sul canale della Giudecca come il giorno del giudizio. Si sarà mossa a una velocità inferiore a quella di un’aristocratica signora inglese molto anziana in passeggiata, ma comunque si muoveva e nulla poteva arrestarla nel suo moto. Mentre lottavo per tenere in rotta Manisse, e assumevo nel contempo quella faccia un po’ così che assumono sempre i morosi quando non sanno più cosa fare e le morose chiamano muso da mona, la zona balistica del mio cervello stava facendo rabbiosamente dei calcoli frenetici.
Calcolo la mia velocità, calcolo la velocità del mostro.
Calcolo la sua rotta e calcolo la mia rotta.
Giungo rapidamente a queste due stringenti conclusioni. Primo: le due rotte sono intersecanti. Secondo: le due velocità sono collidenti.
Ora, io non ho niente contro le crociere moderne su navi gigantesche con migliaia di persone, soprattutto quando portano soldi e possono essere vampirescamente tassate e sfruttate. Però ho tanta paura delle cose grandi. Di ferro e acciaio. Che sputano fumo e muggiscono ferocemente. Già viste da lontano incutono timore. E quando si ormeggiano in Riva degli Schiavoni, o quando passi per le calli e al posto del cielo c’è una fiancata di finestrini, sedie a sdraio e oblò alta come il campanile di San Marco, ho ancora più paura.
So che chi le manovra è infallibile (cioè lo era quando ero lì nel canale della Giudecca, adesso non ci credo più mica tanto) e che sono molto più affidabili di Manisse. Ma io ho paura lo stesso. Inoltre ho anche un motivo storico e sentimentale. Mi ricordano le passate grandesse del nostro lèon e l’orrore dei tempi moderni e vedo quanto la globalizzazione e il presente possa essere gigantesco cieco e ottuso e pericoloso e quanto leggera e debole e piccola e fragile è oggi quella che un tempo era una serenissima potenza mondiale dominante. E, ecco, me vien el gropòn. Ma questo perché sto invecchiando.
Le onde intanto si gonfiano sotto il garbin impetuoso, Manisse geme mentre l’acqua entra in barca e mia morosa terrorizzata mi guarda muta e so che pensa: te lo gavevo dito mi.
Ecco che il transatlantico si avvicina inarrestabile ineludibile inevitabile. Enorme.
E.
Il giònson settecavalli muore.
Con un lamento soffocato.
Guardo mia morosa. Mia morosa guarda me. Guardo il motore morto. Guardo il titanico transatlantico. La zona balistica del mio cervello calcola furiosamente. Calcolo calcolo calcolo. Ho calcolato: ce la posso fare. Tiro la cordicella dell’avviamento. Tiro. Niente. Tiro. Niente. Tiro. Parte! Parte, è partito. Il motore è partito: siamo salvi. Innesto la marcia. Il giònson settecavalli muore. Con un lamento soffocato.
Tiro la cordicella.
Il motore parte.
Le onde traboccano.
Innesto la marcia.
Il motore muore.
Tiro la cordicella.
Le onde spumano.
Il transatlantico si avvicina.
Il motore parte.
Innesto la marcia.
Il transatlantico è più grande di tutto il resto.
Il motore muore.
Tiro la cordicella parte il motore il mostro si avvicina innesto la marcia il motore muore il mostro è qui!
Una calma disumana s’impadronisce del mio cuore. Silenzio ovunque. Tutto è fermo. Sopra di me attorno a me c’è un’infinita curva grigia di metallo. La prora del mostro.
Oziosamente penso ad Archimede al suo bagno ai corpi e ai volumi dei liquidi e penso se sia possibile che l’enorme massa d’acqua spostata dal mostro possa spingere Manisse, mia morosa ed io, distante da quella chiglia brutale che ormai è qui. Mia morosa prende una forcola e un remo ma le onde sono troppe e il remo le sfugge di mano. Tiro la cordicella ancora una volta. Ancora una volta il motore parte. Ancora una volta il motore muore. Non c’è più niente da fare. Siamo immobili al centro del canale in balia delle onde a un passo dalla fine. L’immensa massa cieca di moderno acciaio più grande del cielo non mi ha neanche visto e sta per fracassarmi. Penso che sia questo che mi dispiace, più ancora della tragedia: l’indifferenza.
Ed ecco che. Quando tutto era ormai finito. E pensavo che sì, Archimede mi avrebbe spinto di lato, ma poi le eliche mi avrebbero frullato. Ecco che biondo e possente, abbronzato e a torso nudo, maestoso come un dio greco, un misericordioso motoscafista pien de cavei si affianca a Manisse: «tachève, presto! che ve porto via».