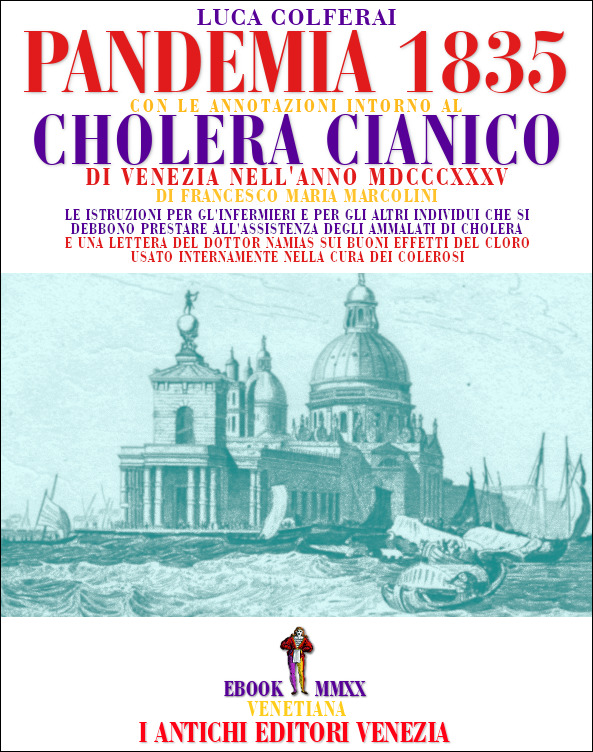La folle avventura del Clown’s Circus
Un prezioso cofanetto di memorie
Ci sono voluti non uno ma ben quattro libriccini, racchiusi in un elegante cofanetto pubblicato da «Edizioni Equilibrando», e curati da Jamila Yasmin Attou, per celebrare come si conviene -tra racconti, testimonianze, aneddoti, poesie e i dipinti di Bruno Edel- la folle avventura della vita breve ma felice del Clown’s Circus di Antonio Giarola. Fu la prima, fondamentale esperienza di circo di regia agli inizi degli anni Ottanta. Uno spettacolo innovativo che avrebbe lanciato il regista verso una brillante carriera sotto gli chapiteaux di mezzo mondo. Il suo era un circo visionario, poetico, sospeso tra fantasia e magia. Felicissimo nella creazione artistica quanto fallimentare sul piano economico. In ogni caso, un’esperienza unica. Da ricordare.
Un cofanetto elegante, raffinato, dipinto con acquarelli sfumati, dai colori antichi e dai profili appena accennati, che come tutti i cofanetti che si rispettino contiene delle gemme. Quattro, in questo caso, una preziosa più dell’altra. Quattro deliziosi libriccini, pubblicati dalle “Edizioni Equilibrando”, che in forme artistiche diverse raccontano la stessa storia: l’avventura del Clown’s Circus di Antonio Giarola, una delle firme più autorevoli e creative del settore, che agli inizi degli anni Ottanta rappresentò la prima esperienza di circo di regia. Un circo poetico, visionario, à l’ancienne, felicissimo nella creazione artistica ma di vita breve e scarsa fortuna (economica).
Il primo di questi libriccini, scritto dalla giovane penna di Jamila Yasmin Attou, intitolato “Il circo, una festa: nuovo modello drammaturgico” (244 pagine), racconta con dovizia di particolari la partenza di questa storia, le tappe della tournée e il suo epilogo, con l’aggiunta di alcune interviste a degli artisti che avevano preso parte all’avventura, come Arno Huibers, Barbara e Giancarlo Cavedo (che era lo splendido clown Cirillino), Gilberto e Isabella Zavatta. Nel secondo libriccino, “IL circo una festa: ceci n’est pas un Cirque”, i ricordi e il diario di viaggio di Ercolano Grazioli, che si era occupato della parte musicale dello spettacolo. Nel terzo, i dipinti del pittore Bruno Edel (sua anche la copertina), che aveva incontrato il circo nel corso di alcuni spettacoli e si era messo a dipingerlo a modo suo. Nel quarto e ultimo libriccino, infine, il più intimo, ci sono le poesie che lo stesso regista, che non da oggi si diletta in rime e versi, aveva dedicato a quel tempo ad alcuni dei suoi artisti, tra cui la sempre amata Elena (la danzatrice Elena Grossule), a quel tempo nei panni del Pierrot.
Triste di luna biacca
scolora la nebbia
il tuo risveglio
che piano poi si dissolve
incipiente alla vita
il sole
Qui di seguito, per gentile concessione dell’editore e dell’autore, pubblichiamo la prefazione al libro scritta da Roberto Bianchin, uno dei più autorevoli critici circensi. Il libro verrà presentato ufficialmente in settembre nella sede del Centro di documentazione delle arti circensi (Cedac) a Verona.
“La differenza la fanno i poeti. E non da oggi. La fanno nella vita, prima di tutto. E in molte altre cose della vita, dalla cultura alle arti agli spettacoli. Perché hanno qualcosa in più: cuori capaci di parlare e occhi che sanno guardare. Sguardi lunghi, che vedono oceani dove gli altri vedono laghetti. Antonio è un poeta. Per come guarda la vita, ma anche per come tiene la penna e conosce la metrica. Per come alza gli occhi e muove le mani. Per i riccioli al vento. Il pizzetto malandrino. Le sciarpine. Per quel parlare quieto come un’onda lunga, per quegli scarti improvvisi come un temporale. Per quegli scoppi di entusiasmi, per quei momenti teneri.
Di mestiere fa il regista di circo, che già è un mestiere bizzarro, il veronese Antonio Giarola, il cittadino più importante di Legnago dopo Salieri. Mestiere che si è scelto fin da ragazzo, che ha voluto fare a tutti i costi e a tutti i costi ha fatto, e che continua a fare con successo in molte parti del mondo, dalla Russia alla Cina, per dire. Divertendosi ancora come il primo giorno.
Mestiere non facile già di suo. Difficile due volte –almeno in Italia, quando Antonio ha cominciato- per la diffidenza, l’ostilità, spesso l’ottusità di molte (non tutte, per fortuna) famiglie del circo tradizionale, per lo più refrattarie alle novità e chiuse verso chi non proveniva dal loro mondo, e magari aveva la pretesa di insegnar loro qualcosa. Testardi. Poco sapienti. Spesso arroganti. Convinti di saper fare di tutto. Di non aver bisogno di registi, sceneggiatori, scenografi, coreografi, costumisti, pubblicitari, ingegneri del suono e disegnatori di luci. Del resto, il primo pensiero del padrone e direttore del circo, era (ed è ancora), quello di sfamare tutti i giorni due volte al giorno uomini e bestie. Che già è questione non da poco. L’ultima preoccupazione, il tipo di spettacolo da mettere in scena, era quella artistica. Ai bambini, pensavano, basta vedere i pagliacci e gli animali.
Logiche così, spesso necessitate, hanno contribuito non poco alla rovina del circo in Italia. Antonio voleva uscire da questa logica. Voleva fare uno spettacolo che avesse un senso che andasse al di là dell’accontentarsi di vedere i pagliacci e gli animali. Ti voleva sorprendere, stupire, sedurre, emozionare per un qualcosa. Voleva regalarti per tre ore un sogno ed un sorriso. Non fu facile per lui farsi accettare, perché non veniva dal mondo del circo, era solo un ragazzo appassionato di quel mondo. Una volta sceso in pista invece fu facile, perché studiava (all’università dello spettacolo, il Dams a Bologna, dove poi si sarebbe laureato), e perché aveva compreso, a differenza di molti circensi, che per fare circo serve cultura. No, non è uno sfizio, è una necessità. Devi studiare. Se resti ignorante non potrai mai fare del buon circo.
Per questo Antonio inventò, agli inizi degli anni Ottanta, con il suo Clown Circus, il primo circo di regia. Lui fu il primo regista di circo. Qualcosa che prima non esisteva in Italia. Riuscì a farlo perché, oltre al talento (ma questo è evidente, è la condizione minima), aveva passione. Perché aveva entusiasmo. Perché aveva cultura. Perché aveva poesia. Quattro attributi indispensabili: passione, entusiasmo, cultura, poesia. Un poker d’assi formidabile. Raro da trovare.
“Poi potevano
gli estri di artisti
mirare ed aggirare
l’esornante accessorio
Potevano tentare
l’illusoria evocazione
guizzi rapidi e fugaci
di cavalli gravidi di luce
E le musiche roboare
sottili diaframmi col reale
quando riaccesero gli occhi
ed animarono di fede
Già non fummo noi
a lustrare il circo di memoria
ma quegli occhi
al cuore nostro ancorarlo”
(Antonio Giarola, “Fiabe”, Edizioni del Leone, 1998)
La poesia, certo. Fondamentale. Ma anche la poesia, da sola, non sarebbe bastata. Non basta. Come non sarebbero bastate, sempre da sole, la cultura, il talento, la passione e l’entusiasmo. No. Serviva qualcos’altro. Qualcosa di unico e potente. Che, anche qui, non tutti hanno. La pazzia. Serviva la pazzia. Una pazzia “sana”, s’intende. Non quella che ti fa sbarellare e dire e fare cose senza senso. Ma quella che ti fa partire per un’impresa solo perché ti piace. Senza curarti troppo del resto, senza preoccuparti, se non più di tanto, di come andrà a finire. Una pazzia che in realtà assomiglia più al coraggio che alla follia. O all’azzardo, se preferite. Del resto ci voleva (e ci vuole) una robusta dose di pazzia per fondare un circo, per aprire un locale ispirato al circo, per organizzare un festival del circo. Proprio come negli anni ha fatto Antonio. Iniziative apprezzabilissime sul piano artistico (le ho frequentate tutte, in una, il Pagoda Circus, sono anche sceso in pista), quanto fallimentari sul piano economico. E’ lo stesso regista, del resto, a invocare per il circo la pazzia. Sentite quanto scrive in un suo intervento nel libro sulla storia della Compagnia de Calza, gruppo storico del Carnevale di Venezia.
“Se estrapolato dalla materialità del suo quotidiano esperire un’attività lavorativa, se interpretato come concetto astratto ma unificante di un insieme di estetiche, il Circo ha sempre vivo nel suo dna il gene della pazzia, perché non è possibile definire in altro modo uno spettacolo che, nella cosciente ricerca dello stupore attraverso l’impossibile, abbia tanta dimestichezza con i sentimenti più estremi, resi poesia dall’ineluttabile senso di vacuità della vita stessa, dall’utopico tentativo di vincerne la gravità del peso fisico e della parola”.
(Bianchin-Bomfim-Colferai, “Storia de I Antichi”, I Antichi Editori, 2006)
Andai a vedere il Clown Circus al parco di Villa Ceresa a Mestre. Era una matinée, mi sembra, bene affollata, di trentacinque anni fa. Non conoscevo ancora Antonio Giarola, e di conseguenza non potevo immaginare che una quindicina di anni dopo ci saremmo messi assieme per fondare un Circo del Settecento (fatto rimasto piuttosto insolito), allo scopo di mettere in scena, in una trilogia dedicata a Casanova, uno strepitoso varietà comico-acrobatico-erotico in occasione del Carnevale di Venezia d’inizio secolo (2000-2001-2002). O per firmare subito dopo le regie di quella Cavalchina al Teatro La Fenice, con un cavallo vero a danzare sul palcoscenico fra acrobati e ballerine, che è stato per alcuni anni lo spettacolo più clamoroso della grande festa veneziana. Di quella mattina di tanti anni fa, la prima cosa che ricordo è un ragazzone alto e smilzo che aspetta gli spettatori all’uscita dallo chapiteau alla fine dello spettacolo, li saluta uno per uno, stringe loro la mano e li ringrazia per essere venuti. Mi avvicino anch’io, tengo per mano i miei figli.
“Io non so lei chi sia…”, gli dico.
“Sono il regista”, mi risponde, con una fierezza contenuta.
“Bene –replico- volevo farle i complimenti. Il suo circo è diverso dagli altri, il suo spettacolo mi ha emozionato”.
Lui mi risponde con un sorriso largo.
Io di solito non ricordo più nulla. Di quello spettacolo ricordo perfettamente, anche a distanza di tanto tempo, la grazia e la poesia (eccola che torna!) del grande mimo olandese Arno, una sorta di padrone di casa, quasi sempre presente in scena, la comicità straripante del celebre clown Cirillino (Giancarlo Cavedo), uno dei migliori “Augusti” del secolo scorso, l’eleganza dei quadri delle ballerinette sul filo e sul cavallo. E, soprattutto, il profumo di quel piccolo circo. O, per dire meglio, l’impronta complessiva. Quella magia che ti faceva capire subito che ti trovavi di fronte a un circo diverso. A cominciare dalla cura dello chapiteau, dall’ingresso che sembrava un tempio, dall’organetto che suonava fuori, dai legni, dai velluti rossi delle poltroncine, da un programma di sala curatissimo, dal rapporto con il pubblico, con cui gli artisti entravano in contatto diretto, per colorare un naso o regalare un biscottino, prima ancora che lo spettacolo iniziasse.
Cose d’antan, fascino di altri tempi. Ben studiato e ben riuscito. Circo della memoria, certo, cirque à l’ancienne, come amano dire i francesi. Ma con spunti originali propri, come i rimandi alla storia del teatro, alla commedia dell’arte, alle maschere della tradizione, ai guitti, ai carri dei comici, persino alle baracche dei burattini. E per contro, dentro a tutto questo, innovazioni modernissime, come un impianto luci molto sofisticato, più da teatro che da circo, la cura maniacale nei costumi, disegnati tutti appositamente, e nelle musiche originali (ben lontane dalle vecchie, ormai insopportabili marcette, peccato per la mancanza di un’orchestra dal vivo), composte anch’esse per l’occasione. Quasi un anticipare, con la sceneggiatura e la regia al posto di una semplice sequenza di numeri, certo stile del miglior circo contemporaneo, come l’uso della danza classica per introdurre le attrazioni. Qualcosa, in sostanza, di mai visto prima. Il circo dei sogni. Uno scrigno prezioso di stupore e meraviglie. Rivoluzionario ed esplosivo ma nel rispetto della storia e della tradizione più pura.
Quanto agli animali, al circo Clown c’erano solo cavalli, cavallini e cagnolini. Anche qui, quasi un’anticipazione del circo del futuro, che sarà senza animali, date le mutate sensibilità e le nuove leggi varate (a torto o a ragione, non è questa la sede per entrare nella discussione), da molti Paesi. Il Barnum prima ha tolto gli animali e poi ha chiuso i battenti. Il Pinder, dove pure il figlio del padrone mandava un numero di gabbia con 17 tra tigri e leoni, ha rinunciato agli animali. Anche il Roncalli non ne ha più neanche uno, li ha sostituiti con degli ologrammi. E il Knie, con una decisione shock, ha mandato a casa persino gli elefanti, il suo marchio di fabbrica. Ora gli restano solo i cavalli. Così anche da Alexis Gruss. Tra un po’ non ci saranno più neanche i cavalli.
Antonio Giarola non è un regista animalista. Non ha mai combattuto contro gli animali nel circo. Anzi, proprio con degli animali (cavalli) ha firmato alcuni dei più bei numeri equestri, premiati in mezzo mondo, da Montecarlo a Mosca. Questo per dire che la scelta del Clown Circus di non avere animali, tranne i cavalli, fu tutt’altro che ideologica. Accadde perché da un lato non c’erano i soldi per comperare anche degli animali oltre alle attrezzature, e dall’altro perché Giancarlo Cavedo, comproprietario dell’impresa, aveva deciso di non tenere più animali in gabbia dopo l’incidente capitato alla figlia Barbara, come potete leggere in questo avvincente volume, che mi ha rivelato molte cose che non sapevo, redatto con cura e passione da Valeria Bolgan prima e da Jamila Attou dopo. Del resto, a dispetto dei male informati, anche il mitico Cirque du Soleil, presentato ai gonzi come l’antesignano dei circhi senza animali, il paladino più fiero dell’animalismo più spinto, non ne aveva solo perché all’inizio non c’erano i soldi per comperarli, come ha raccontato lo stesso Guy Laliberté, uno dei fondatori.
In ogni caso, animali a parte, l’avventura del Clown Circus ebbe vita breve e si concluse in modo fallimentare. Fu accolto mediamente bene dalla critica, mentre gli spettatori non furono mai moltissimi. Quelli che lo videro ne rimasero però entusiasti. Com’è stata possibile, allora, una fine così misera, se lo spettacolo di quel circo, a detta di molti, compreso di chi scrive, non era affatto male? La causa, l’esperienza insegna, non è mai una sola. In questo caso entrarono in gioco diversi fattori negativi, che alla fine risultarono di gran lunga superiori agli aspetti positivi. In primis, il pubblico italiano di quegli anni non era ancora pronto per uno spettacolo così innovativo, che pescava nella storia del circo e lo proiettava in avanti ai confini del teatro e della danza. In secondo luogo, uno spettacolo di questo genere avrebbe avuto bisogno, per imporsi all’attenzione del grande pubblico, di una campagna pubblicitaria massiccia, e quindi molto costosa. Terzo, avrebbe avuto bisogno di un solido impresario alle spalle che credesse nel progetto e vi investisse cifre ben più consistenti (un giovane regista e un non più giovane clown non potevano da soli fare miracoli). Quarto, sarebbe servito un diverso rapporto con enti e istituzioni che, in questo caso, sono rimaste indifferenti quando non anche apertamente (stupidamente) ostili.
Fu un’esperienza che segnò comunque un punto di non ritorno nella storia del circo italiano. Anche nell’uso del linguaggio. Esemplare il dialogo iniziale tra Pinocchio ed Arlecchino (anche questa una bella bizzarria), in un curioso grammelot dagli accenti più basso veronesi che veneziani. Scelta registica azzardata, anche qui, all’apparenza incomprensibile (qualcuno anche lo scrisse), minoritaria, provinciale, campagnola. Tutto il contrario. Scelta forte invece, precisa, identitaria, anticipatrice (dice niente il Montalbano di Camilleri?), nonché omaggio alla maschera italiana più famosa e alla terra di origine del piccolo circo più poetico e sognante del mondo. Perché è solo nei dialetti, che spesso in realtà hanno la dignità di lingue vere e proprie, che si esprimono i sentimenti più profondi, dalla rabbia al dolore all’amore. Il dialetto natìo è la lingua primordiale, la più vera, quella del cuore e dell’istinto. Quella della poesia. Perché la differenza la fanno i poeti. Così nella vita come al circo.
El tendòn
gera
picolo
roto
piturà
de blu
do veci
rivava
coi nasi
rossi
e coi cavèi
panocia
dai busi
se vedeva
le stele
(Roberto Bianchin, “Calìgo”, Filippi Editore, 1995).