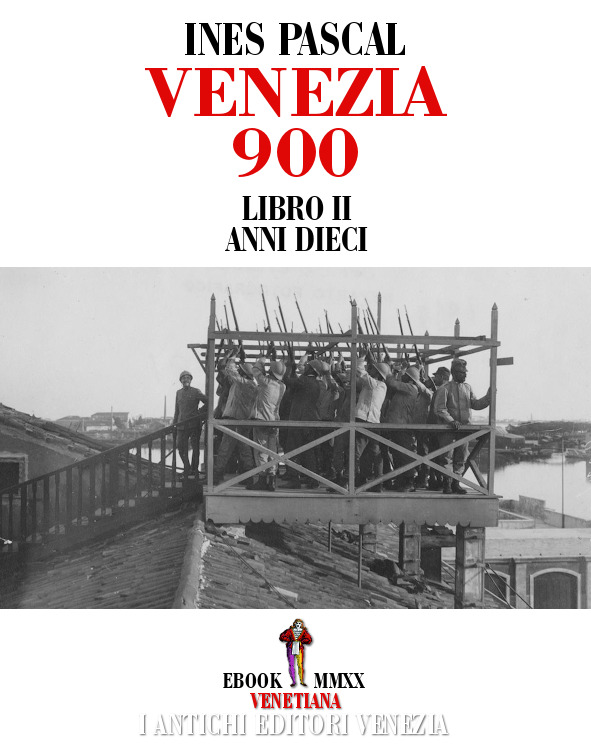La cattedrale sull’acqua
Torre di Fine e la grande bonifica
Imponente e maestosa come una cattedrale, l’idrovora di Torre di Fine si specchia nell’acqua verde-oro del canale Ongaro, largo e profondo come un fiume, che convoglia le acque della Bonifica nell’altro canale, il Revedoli, che le riverserà poi nel Piave. Il livello dell’Ongaro, lo vedi, è molto più basso del Revedoli: l’idrovora serve a risucchiare le acque basse e pomparle fuori dei territori coltivati. Questa è in sintesi la bonifica: equilibrare i livelli delle acque dolci, prevenire le piene, sanare e rendere fertili e coltivabili gli acquitrini, garantire l’irrigazione nei tempi di siccità.
Qui, tra Concordia, S. Stino, Cessalto, San Donà, Eraclea e Jesolo, senza le idrovore potremmo trovarci sott’acqua da un momento all’altro. Ci son voluti almeno centocinquant’anni per rendere stabile e sicuro il territorio: un secolo e mezzo di lavoro, schiene spezzate, lacrime, sangue e portafogli vuoti. Cospicui investimenti non sempre dall’esito fruttuoso, ma soprattutto uomini lungimiranti che hanno saputo rischiare soldi ed energie per strappare questa terra all’acqua marcia, alla malaria e alla pellagra, e renderla fertile, facendola diventare una vera e propria terra promessa per loro e per la miriade di famiglie contadine che l’hanno popolata e lavorata, superando le devastazioni delle Guerre e ricominciando da capo ogni volta con ritrovata volontà ed esemplare giudizio.
La storia della Bonifica rende onore all’operosità dei Veneti: fu ed è ancora oggi un modello. Peccato solo che me ne sia accorto tardi.
Un giro in bici
Tu sei qui per le vacanze, per la spiaggia e il mare, lo so, sei stanco del lavoro e hai solo voglia di ritemprarti al sole dell’Adriatico ma, visto che hai ancora pazienza di ascoltarmi, be’, sappi che anche la mia famiglia ha dato del suo, in queste terre. Mio nonno e mio padre sono nati qui a Eraclea, più a monte, in una grande casa proprio davanti all’argine del fiume. Veri contadini razza Piave, anche se poi se ne sono dovuti andare una decina di chilometri più a nord. Mio nonno fu tra quelli che buttarono su una alla volta, col paeotìn, le pietre della chiesa di Eraclea. Lui, i suoi otto fratelli e i relativi figli e figlie hanno lavorato tutti qui, anche se poi la vita li ha portati altrove. Un po’ me ne vergogno, sai, per non aver dato ascolto in tempo ai loro racconti, per non aver capito… ma non è mai troppo tardi, almeno spero, per dare il giusto valore alle imprese di chi ha vissuto prima di noi.
La storia della Bonifica, se t’interessa, tu saprai come trovartela da solo: ci sono libri e musei. Ci sono anche i nomi, le facce, le immagini. Io, qui, posso solo portarti a fare un giro in bici a vedere un paio di idrovore, le cattedrali dell’acqua.
Prendiamo la via verso Caorle, quella asfaltata. Là in fondo, dopo il camping, gireremo a destra: la vedi la canaletta di cemento rialzata e il lungo filare di aceri e pioppi che taglia la campagna?
No signora, ho il blocchetto in mano ma non sono un vigile in borghese che sta mettendo multe, no: sto solo prendendo appunti!
Prudenza, sulla curva: oltrepassata la sbarra saremo al sicuro, sulla strada di sassi preclusa alle auto.
Il canale qui a destra si chiama Livenzuola e va su fino al Revedoli: l’acqua è placida, ora addirittura stagnante, piena di erbe. Gazze, colombacci e tortore, e lo stormire invitante delle fronde e le ombre del filare di alberi che servivano per riparare carri, bestie e carrettieri dal sole. A destra ruderi di case coloniche, a sinistra lunghi stradoni che fiancheggiano il reticolo dei canali minori: una coppia di lepri e un tris di aironi, di quelli rossi, a convegno sulla riva. Lontani quanto basta per scorgerci e rintanarsi svelti tra le colture. Mais e soia, soia e mais e, mentre poco distante la spiaggia ribolle di frenesie, qui vige la massima quiete. La natura lavora in silenzio, senza fare chiasso. Le gambe del granoturco s’ubriacano di sole e pompano linfa ad ingrossare le pannocchie: senza clamori, senza bisogno di farsi pubblicità.
L’acqua del canale è opaca, color verde oro; una paperella vagabonda, insetti d’acqua, qualche pescione che salta fuori ogni tanto, mentre minuscole anatre giocano a rintanarsi tra i canneti.
Il filare d’alberi termina: qualche centinaio di metri di strada candida e siamo sotto i gradini dell’idrovora dai vetri colorati. Bacino Livenzuola Ossi, Consorzio Ongaro inferiore, come recita la scritta ormai corrotta dal tempo. Saliamo: davanti al manufatto in pietre rosse il livello dell’acqua è molto più alto. Pareggia quello del Revedoli, da cui attinge (o in cui riversa) attraverso le chiuse. A sinistra la grande azienda agricola, in parte deserta: due filari d’alte arcate in mattoni ancor più rossi, sili, la casa padronale e il mastodontico caseggiato dei fittavoli, dei braccianti (ma quante famiglie ci vivevano qui?). L’apparente disordine operoso di macchinari e strutture, disposti sulla smisurata aia di cemento grande come un campo di calcio, pronti per essere rimessi all’opera; poi stalle, depositi, cantine, granai, concimaie…
Rari ciclisti passano svelti, ma noi scendiamo un attimo dalle bici: indaghiamo con lo sguardo sul livello delle acque, sulla casa nascosta tra gli alberi, sullo stradone che prosegue sulla destra, sulle inferriate delle finestre al piano terra, sul banano a piè dell’argine che nasconde la prospettiva delle arcate di pietre sospese dei due fabbricati che terminano, in fondo, con la torretta della centrale elettrica, costruita più recentemente.
Un gatto in agguato, lo sguardo fisso su un buco dell’argine, ma è troppo occupato per notarci. Ripartiamo, contro sole, sulla strada sopra l’argine sinistro del Revedoli; sotto il ghiaino spuntano i grossi sassi del vecchio selciato, quelli caricati sui greti trevigiani del Piave e portati qui con le barèe, i carri a due ruote trainati dai buoi. O con le chiatte, direttamente dal fiume risalendo i canali: vedi che se ci ragioni un attimo ci arrivi anche tu?
Torre di Fine
Oltre il ponte girevole, a destra, c’è Torre di Fine. Siamo qua, proprio davanti alla darsena. A sinistra la torre dell’acquedotto: l’acqua potabile viene pompata su per poi diramarsi, in caduta libera, in mille tubi e rubinetti. Davanti la chiesa di San Ferdinando Re (la candida statua a sinistra, con scettro scudo corona e manto regale, che con ieratica compostezza scruta l’orizzonte davanti a sé), restaurata fresca fresca e decorata al suo interno dalle nuovissime opere di don Paolo veneziano, sulfureo liberissimo artista tanto colto ed efficace nella sua ars divulgatoria quanto generoso e premuroso nella disponibilità verso gli ospiti.
Il complesso religioso ancora in evoluzione, frutto anche delle donazioni della famiglia Wallner, col suo campanile rustico atterrato (qui un campanile normale sarebbe stato ingoiato dalla palude) delimita da sinistra l’area urbana della borgata. A destra (sempre per noi che veniamo dal ponte girevole) il grande prato risistemato ex novo fa da cornice al profondissimo canale di scolo, anche lui riscavato e raddrizzato l’inverno scorso: questo, caro mio, è l’Ongaro Inferiore. Porta l’acqua che scende dalle campagne di Valcasoni, Boccafossa e Crepaldo fino a quella costruzione lì. Che adesso andiamo a vedere da vicino. Scendiamo, non aver paura, occhio solo a non avvicinarti troppo all’acqua e a non caderci dentro, dev’essere profondissima, qui.
L’idrovora centrale di Torre di Fine fu terminata nel 1925. Tutta di mattoni cotti in fornace, mentre lo stile è quello dell’architettura tipica rurale di quegli anni lì: ha tre arcate con una serie di vetrate da cui l’interno prende luce, due blocchi laterali con altrettante finestre. Davanti e dietro, all’apice delle colonne, è decorata da sculture: mascheroni di leoni e satiri, figure inquietanti di mostri (la malaria, la pellagra?) e, più in basso, da piastre di pietra bianca scolpita. Quelle sul retro è difficile decifrarle, siamo troppo distanti. Quelle della facciata sud, coperta dalle fronde dei pini che si nota dalla strada, invece sì. Il primo a sinistra, sotto il faccione leonino, la figura alata con lancia e scudo, è Michele Arcangelo, quello che giudica le anime al momento del trapasso e che guida le schiere celesti alla vittoria contro l’esercito del maligno. È uguale allo stemma della città di San Donà di Piave, forse vuole ricordare il famoso ed ancor più importante Congresso nazionale della Bonifica tenutosi proprio là nel 1922. Michele, mi pare di ricordare, sovrintende anche alle acque: deve qui proteggere forse dalle inondazioni? Il secondo, sotto il mascherone con la bocca di pesce, pare uno stemma gentilizio: uno scudo con la croce, spalleggiato da pennacchi, sovrastato da una corona regale e, alla base, canne palustri con tanto di code di gatto (i Savoia? Lo stato Italiano artefice della grande Bonifica? Qui dovremo indagare ulteriormente, mia cara…).
Il terzo, sotto un altro bizzarro mascherone (erano forse dei gargouille ispirati alla moda d’oltralpe?) rappresenta una snella e aggraziata torre medievale (l’antica Torre di Fine…) a cinque piani, dalla cui cima sventola una bandiera. Il quarto e ultimo lastrone scolpito a bassorilievo, sottostante il solito grottesco faccione, raffigura un altro angelo. Di forme più rinascimentali, ali e braccia aperte, s’erge a proteggere le tre torri e la cinta muraria d’una città (è lo stesso dello stemma ufficiale di Caorle).
Dentro (puoi solo tentare di fotografarle mettendo la macchinetta oltre il vetro rotto) una serie di gigantesche turbine a forma di chiocciola dipinte di nero ancorate al pavimento, rosso, e piastrelle bianche da mattatoio alle pareti.
A fianco, congiunta da un leggiadro porticato, la casa del custode, altrettanto grazioso villino liberty. Ma basta, muoviamoci, siamo appena a metà percorso.
L’immensa fertile distesa
Il resto è sole e ginnastica: presa via Vallesina saliamo ancora a fianco del Revedoli. «Il solco è aperto»: parla chiaro la scritta sotto il bassorilievo sulla facciata della barchessa a destra. Un uomo in elmo e gonnella (antico miles limitum romano?) guida l’aratro trainato da una coppia di buoi. Ma una delle due bestie (femmina?) pare imbizzarrirsi, e allora alle sue spalle appare un’altra figura, coi capelli raccolti sulla nuca (altra femmina?) a trattenerla per le corna. Un’altra aia, ne vedremo lungo i tre chilometri che ci separano dalla Fagiana, la risaia. L’acero squarciato dal fulmine resiste, le canne d’india pure. La canaletta a sinistra è secca, la vecchia stalla è dismessa. Un punto di sosta, la cantinetta: vini, bibite e panini, mentre dalla parte opposta la riva del Revedoli ripulita dal canneto lascia spazio ai pali dell’approdo.
La campagna apre alla vista la sua immensa distesa fertile. Un paesaggio regolare e ordinato di mais e soia, un filare di piante ad ombreggiare lo stradone, la carezzevole chioma erbosa del riso più pregiato. E un bestiario completo sorpreso a raduno al margine della coltura: lepri, cornacchie, gazze, aironi.
Ora nel fossato ricompare l’acqua, solcata da piccole nerissime anatre neonate dal beccuccio rosso che scappano a rintanarsi avvisate dalla madre e, in fondo, la sagoma della villetta neogotica da restaurare, col fabbricato crollato alle spalle. Il cartellone sulla passada annuncia che siamo arrivati alla Fagiana, l’azienda agricola della risaia. Giusto qualche metro più avanti però, nascosto dentro al fossato, tra le erbe alte, un girasole solitario nato all’ombra si specchia, novello narciso, sulla pozza d’acqua che riflette proprio la luce del sole. Qui anche le piante, al pari delle persone, non si perdono mai d’animo e sanno sempre, anche nelle situazioni avverse, come cavarsela al meglio.
Entriamo in risaia, dai, vediamo cosa c’è di buono. Qua producono il Carnaroli, il riso più pregiato; ti fanno girare in bici tutta l’azienda e, quand’è la stagione giusta, allagano pure i campi con l’acqua del canale, vedessi che spettacolo… anche con la luna piena… ma ne riparleremo.
Poi ripartiamo con calma, accompagnati dal sole gentile del tardo pomeriggio, con davanti agli occhi le teorie lussureggianti dei filari d’alberi oltre il canale. Attraversiamo il ponte della darsena e prendiamo a destra, stavolta, fino in fondo a via Lungorevedoli. La centrale elettrica e, dopo il profumo dell’allevamento, il caseggiato bianco. Qui si va a sinistra, finisce la strada bianca, si ritorna sull’asfalto e quindi in centro a Eraclea mare.★