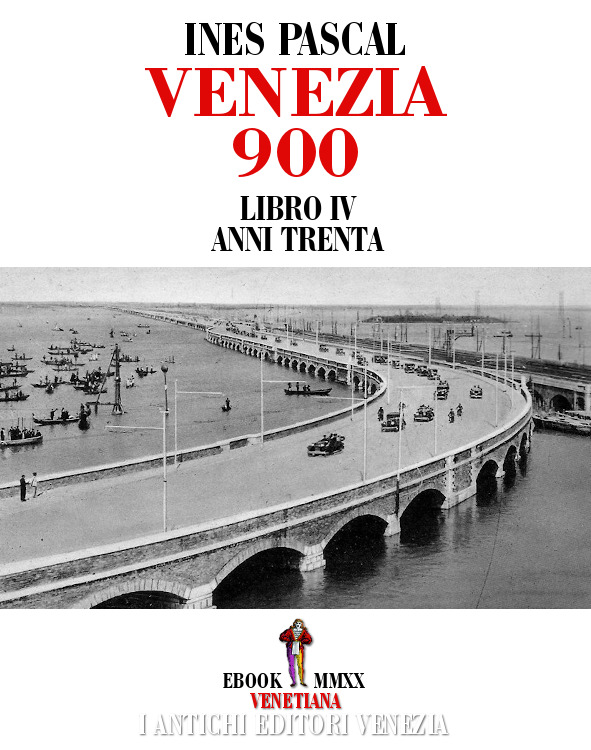Torre di Mosto, l’isola circondata dalla terra
La strana storia di un paese che ha cancellato i propri ricordi
Ho deciso finalmente di rivelarlo: il luogo, anzi il paese di partenza e arrivo del mio continuo viaggiare, e da dove scrivo anche le note di questo Sprofondo Nord, si chiama Torre di Mosto. Quasi cinquemila anime umane attorno al municipio del 1905 e alla parrocchiale della fine del Settecento, al centro del triangolo piatto di bonifica tra San Donà, Portogruaro e Caorle.
Nome e cognome non hanno nulla a che fare col vino; furono affibbiati nel medioevo a questo ritaglio di palude dai da Mosto, il nobile casato veneziano di origine lodigiana (il loro duecentesco avito palazzo dei Santi Apostoli, sul Canal Grande di fronte alle Pescherie nuove, sta ancora aspettando di essere restaurato). Casato che nel 1432 diede anche i natali a quell’Alvise scopritore delle isole di Capo Verde.
Torre di Mosto in origine era un’isola veneziana, quindi. Anzi le isole erano due, la motta sopra cui i Da Mosto costruirono la torre di guardia, e Melidissa (in medio lidis), lingua di terra rialzata tra fango e barene, argine e riva dell’antico e ora scomparso Lago della Piave (ci abito io).
Ma qui, dove i fiumi sono femmine come in Francia, con la Piave non abbiamo nulla a che fare, siamo tenuti in braccio dalla Livenza, il fiume profondissimo e infido che per un lungo tratto segna il confine tra Veneto e Friuli. Insomma, tra alluvioni tagli interramenti e bonifiche qui il terreno ha preso l’attuale conformazione da poco meno di un secolo.
Qui comandavano i veneziani ma poi, stanchi di guerrigliare coi passanti, lo vendettero al vescovo di Ceneda, le cui navicelle potevano così trafficare su e giù dal Portus Buvoledi fino al mare senza dover pagar dazio a quel Polo Da Mosto inventore delle palade, le dogane estemporanee di pali infissi nel corso dei canali. Naturalmente abusive. Palade che poi scomparivano e ricomparivano più in là a tradimento.
Torre di Mosto è un’isola, anzi due, molto particolari, se non uniche: due isole saldate tra di loro ma non contornate dal mare, bensì dalla terra. Due isole a galla in un mare di terra, proprio al centro di tre grandi bonifiche: quella delle Sette sorelle a Nord, quella del Basso Piave a Sud-Ovest, quella dell’Ongaro inferiore a Sud-Est.
Paese, terra di viaggiatori, questa, di rappresentanti, di muratori e di commercianti. Sin dai tempi dell’illustre Alvise, Luis de Cadamosto (detto alla portoghese), oppure Kodemosta, il nome che resiste nella tradizione orale dei Woloff, principale ceppo etnico senegalese. Scrisse dei solenni diari di viaggio (editi dal Ramusio, donati dai Savoia alla Marciana) l’Alvise navigatore, raccontando per filo e per segno le sue due spedizioni lungo la costa dell’Africa. Partendo da Sagres, in Portogallo, attraverso le Canarie per finire a risalire il Rio de Senega de negri, come lo chiama lui e dove se lo ricordano ancora; il tutto per conto dell’infante portoghese Dom Enrique. Personaggio quasi sconosciuto, qui, venuto alla ribalta per puro caso.
Ecco ora l’inghippo: a differenza dell’antica madre Venezia, che ha conservato intatto il suo splendore artistico letterario e architettonico votandolo allo studio storico-scientifico e al turismo, qui invece, in questa isola figlia degenere dimenticata della madre-matrigna Serenissima, circondata dalla terra strappata alla palude, è avvenuto esattamente il contrario.
Qui, difatti, tutto ciò che poteva essere, o diventare, turistico culturale letterario o ambientale, è stato prontamente distrutto. Volete l’elenco? Ecco qua.
I resti dell’antica Civitanova Heraclia, abbandonata dagli abitanti fuggiti al sicuro verso Rivo Alto (la Venezia ancora in via di fondazione) le cui vestigia rimangono sotto terra; il porto romano di Busatonda sul Canal Nero (da cui affiorano ancora grossi tronchi pietrificati lunghi sei-otto metri oltre che imponenti pietre squadrate che sembrano le gemelle di quelle di Aquileia); il ramo della Via Annia che faceva da scorciatoia dal ponte romano di Ceggia fino a (Julia) Concordia Sagittaria; il monastero benedettino di san Lorenzo della fine del Trecento (ma rimane una statuina in pietra scura della Madonna del latte, rinvenuta sepolta in un campo); i palazzi del Quattrocento (palazzo Da Mosto in primis); la loggia del Cinquecento; la chiesetta di Sant’Elena (di cui rimane la lapide tombale di una intera famiglia sterminata dalla peste, murata altrove); la cripta di san Martino (il cuniculo ecclesiae degli antichi registri parrocchiali), lo squero navale di Portus Liquentiae; palazzo Barbarigo (sopra le cui fondamenta fu poi edificato il nuovo municipio); i pontili e gli attracchi veneziani sotterrati a sant’Elena; le vestigia dei Morlacchi stanziati qui dai veneziani.
Tutto scomparso, l’unica memoria che ne rimane sono i disegni tracciati dai pertegadori sulle antiche mappe conservate nei catasti veneziani.
Demolita la casa delle due ragazze guarite prodigiosamente (l’8 settembre del 1909 e venticinque anni dopo, lo stesso giorno, nel 1936) per l’intercessione della Beata Vergine delle Grazie. Scomparsa, demolita una ventina d’anni fa, persino l’ottocentesca casetta dell’emigrante di via Roma, quella in pietra facciavista uguale a quelle che, in Brasile, costruivano gli emigranti veneti e che ora sono diventate monumenti nazionali.
Ma non finisce qui. Scomparsi, forse distrutti, anche gli originali delle poesie di Piero Nardo, il poeta sacrestano nato nel 1863 e morto ultranovantenne a Milano. Spariti tutti, tranne un foglio, anzi due, capitati miracolosamente in mano mia. Un vecchio arciprete mi raccontò che il Nardo aveva tradotto in veneziano l’intera Divina commedia. Persa anche questa. Come l’arco in pietra della sua vecchia casa in riva all’argine, e quello della vecchia canonica.
Demolita l’imponente Locanda alla Nave, in cui albergarono per quasi due secoli i viaggiatori che navigavano sulla Livenza. Scomparsa, rasa al suolo, anche la casetta in cui fu mandato in pensione l’ultimo boia austriaco di Venezia: un anziano signore che da ragazzo la vide demolire mi raccontò che per completare il lavoro tolsero anche il lungo viottolo d’ingresso. Damnatio memoriae, in effetti non era nemmeno un paesano. Dicono sia sepolto in zona, senza nome, si tace il posto ma si sussurra che se qualcuno accende una candela sopra la sua tomba, la fiamma si spegne subito.
Scomparso, interrato, anche il primo secolare canale, la Xola (da ixola), che girava attorno all’isola della torre dei Da Mosto, canale storico che riemerge per qualche centinaio di metri nella zona periferica dell’Ecocentro.
Può bastare? Mica tanto, se è vero che qualche anno fa sono state abbattute le decine di piante del giardino imperiale asburgico davanti al municipio, accusate e condannate a morte solo per non essere autoctone: si è salvato il gigantesco cedro del Libano, l’albero con cui fu costruito il Tempio di Gerusalemme, ma solo per farne l’albero di natale. E i due tigli davanti all’ingresso del municipio: il tiglio, la linte, la pianta sacra agli antichi Veneti, che Bepi De Marzi immortalò in una delle sue canzoni più delicate e struggenti, Dolinta.
Dell’oro del Montenegro invece, paracadutato nei campi attorno a Boccafossa e Senzielli verso la fine della Guerra e sepolto sotto il pavimento d’una chiesetta, non si è saputo più nulla. Ne scrisse anche Hugo Pratt in una storia di Corto Maltese, ma forse lavorò di fantasia. Invece qui qualche vecchio, a dentiera stretta, si lascia scappare il nome d’un famiglia di repetini, braccianti, che di colpo s’è trovata padrona di duecento ettari di terreno agricolo.
Il vecchio ponte ad archi della Triestina invece l’hanno lasciato, deviando la statale sul ponte nuovo costruito a fianco. Il ponte vecchio dicono sia pericolante, ma a sentire solita malalingua cadrà prima quello nuovo.
Qui la gente, riparata dalle grosse vie di traffico, ha avuto modo di conservare la memoria di tutto, dai casoni palustri alle esse esse che verso la fine della Seconda guerra giravano per i campi alla ricerca della loro base segreta, così segreta che nessuno ne sapeva nulla e stentavano a trovarla pure loro. Sanno che lì, accanto all’argine, una volta c’era un cimitero. Sanno dove stanno sepolti, sotto due metri di terra, i resti del bombardiere americano abbattuto dai tedeschi. Sanno dove sta, in fondo alla Livenza, il barcone affondato da cui qualcuno ancora riporta in superficie elmetti e giberne. Sanno tutto perché sono vent’anni che perlustrano i campi col metal detector. Sanno anche che la TAV, la linea del treno ad alta velocità, non passerà mai sopra i campi dei Morlacchi: è terra molle e infida, qui la ferrovia sprofonderebbe e verrebbe inghiottita; si dice che una vecchia maga dei campi gli abbia addirittura gettato contro una maledizione. Qui è soprattutto terra di broli, di orti e di donne e uomini che li coltivano. Terra benedetta da Dio, fertilissima, che se per dispetto sputi un seme per terra, attecchisce subito e al momento giusto raccogli frumento e pomodori anche tra le crepe del marciapiede.
Anche ora che tutti i canali sono diventati strade, il paese rimane comunque isola, non solo nella mentalità degli antichi, se ne accorgono anche i foresti. E ritorna isola agli occhi di tutti nei giorni delle piene, quando la Livenza si riempie d’acqua torbida e minacciosa fino al colmo degli argini. Un qualcosa di veneziano atavico, una supponenza riservata, un intrigo latente, c’è rimasto, è una componente pregnante del genius loci. Un groviglio di razze in perenne transito, qui ogni famiglia proviene da qualche parte, lo si legge nei cognomi: furlani, zuliani, carnielli, polesani, trevisani, veronesi, visentini, foresti, montanari, boatti, cìgani, boemi, stradiotti, pogliani, zaratini, crovati.
Come anche la parlata, la koiné liventina, dolce e delicata come il furlan delle basse, con quella zeta austro-slava che assomiglia al ronzio delle zanzare kamikaze assetate di sangue caldo. Qui si divide ancora il mondo tra «noi torresani» e «quelli da fuori». E anche se qui non ci sono mai stati leoni di San Marco né scolpiti né dipinti, rimangono e riecheggiano potenti i nomi dei casati, non solo veneziani, dei vecchi proprietari terrieri, i primi pionieri che azzardarono a scommettere sulla bonifica e fecero curare col chinino le insidie della mala aria. Nomi suggestivi di storica memoria, navale e dogale, le cui ville ora giacciono umide e deserte per gran parte dell’anno, aspettando la villeggiatura estiva nascoste da una cortina di piante e boscaglie ultracentenarie.
Ironia della sorte un museo, anzi due, ci sono pure qui, e addirittura uno di fronte all’altro. E addirittura ancora, altra ironia della sorte, nemmeno in centro ma in una zona difficilmente raggiungibile e con stradine da rally circondate da profondi e larghi canali pescosi. Il primo, quello nuovo ospitato in un edificio anonimo perché moderno, vecchio solo di qualche anno, cangiante e aperto a intermittenza, è il Museo del Paesaggio. Il paesaggio di altre zone, naturalmente, che qui è tutto piatto e non riesci a fare una foto senza prendere dentro all’inquadratura una decina almeno di segnali stradali. Poi c’è l’altro museo, quello della Civiltà contadina, un monumentale sacrario con oltre ventimila reperti e residuati anche enormi e quasi tutti ancora pericolosamente funzionanti. Di iniziativa privata, ospitato sui tre piani di una gigantesca barchessa inizio Novecento. Un incubo gotico campestre che se lo vede Pupi Avati gli prende l’angoscia creativa e ci fa minimo altri tre film tipo La casa dalle finestre che ridono. Sto museo-sacrario in memoria delle schiene rotte e delle partorienti sui campi, pieno di attrezzi arredi e bestie (vive e impagliate) e fantasmi, ha un unico famoso custode, tremendo vigile e potente, che comanda tutto lui e apre solo a chi gli è simpatico, talvolta nemmeno a quello. Casualmente, per vie traverse, ci arrivano contemporaneamente quattro corriere di furlani benestanti assortiti: con la scusa del museo fanno sagra e marenda sull’aia e poi via. E zitti, che non si sappia troppo in giro.
Insomma qua è così, il turismo ci è sconosciuto. Non ci avevo fatto caso, me ne sono reso conto all’improvviso sentendo la coppia di ciclocituristi con guida e cartina, sulla piazza del municipio, chiedere a una signora che passava con le sporte in mano: «Scusi, cosa c’è da vedere qui?» La signora si fermò, posò le sporte, li guardò. Poi ristette un attimo e rispose: «Niente».
Riprese le sporte in mano e se ne andò. ★