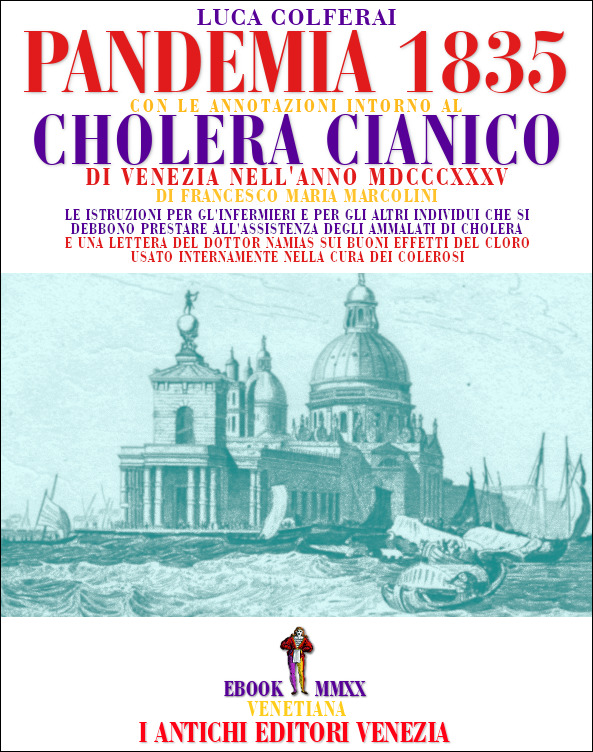Il pallone che muore
fra tifo violento
e stadi vecchi
Come avanza il degrado
dello sport più bello del mondo
Sempre meno spettatori nei campi di calcio divenuti squallide cattedrali nel deserto in balìa di bande armate rivali le cui gesta non hanno spesso più nulla a che fare con lo sport.
VENEZIA — Il tornado che lo scorso giugno ha divelto il muretto esterno alla curva sud dello stadio di Venezia non era una metafora.
I mattoni sono caduti, hanno fatto male al cuore: ma se i graffiti scrostati sono stati tosto ricostruiti, più difficile da rimarginare è la ferita da martello sul capo di Andrea, colpito qualche mese più tardi da una mano che avrebbe dovuto essere amica, vicina di posto, innalzante la medesima sciarpa arancioverde per le calli della città.
Com’è potuto accadere che anche in un ambiente come quello lagunare — solo pochi anni prima latore di un diverso messaggio alla sociologia ultrà — il cuneo della dissidenza politica abbia fatto breccia tra le file della gradinata, al punto da costringere una delle componenti più calde (il Gate 22, cui apparteneva l’aggressore, e che subito dopo i fatti si è sciolto) all’autoesilio fra i distinti laterali, e in prima istanza l’abbandono del Pier Luigi Penzo da parte di molti aficionados?
Non bastasse il ripiegamento della squadra nelle serie inferiori, il fenomeno va inquadrato nella congiuntura storica in cui versa l’intero indotto del calcio italiano — specie se raffrontato alla salute goduta dai principali campionati esteri — e chiama in causa l’obsolescenza degli impianti e delle norme, sorvola l’egocentrismo di taluni dirigenti societari divisi tra commercio e impero, solletica i bassi istinti nelle aree del disagio ed è a sua volta parte non marginale della regressione italiana in corso, segnatamente verso le forme del bello e quelle che un tempo costituivano le piccole soddisfazioni di classi modeste ma dignitose, oggi atomizzate e sempre meno comunitarie.
Se è vero che in ere geologicamente non lontane la tifoseria abituata a salire i tubi Innocenti di Sant’Elena era stata capace, unita sotto le rimpiante bandiere degli Ultras Unione, di finanziare la costruzione di uno stadio per gli indios del Messico nonché di organizzare molte manifestazioni in terraferma a contenuto antirazzista, nei capoluoghi vicini non erano rose e fiori, bensì un terrapieno in luogo della terrace nel recente stadio Euganeo di Padova, o ridicole sagome di carta dipinte nelle tribune del Nereo Rocco a Trieste per sopperire all’affluenza men che negativa rispetto ai fasti.
Non è, con ogni evidenza, una questione limitata al rapporto tra la fruizione pubblica della cerimonia calcistica outdoor e l’interesse venuto meno, fiaccato a colpi di pay-tv satellitare o dirette in streaming sul web: la crisi coinvolge gli impianti, molti dei principali ritoccati — ma non ripensati — in occasione dei mondiali ‘90 (mietendo anche vittime operaie all’altare del fare presto «che è già tardi»).
I terreni di gioco presentano larghe chiazze sterrate e senz’erba: dal Bentegodi al Tardini, dall’Olimpico di Roma al San Paolo di Napoli, al primo acquazzone promettono di non drenare le pozzanghere né le assorbono al di là delle fasce, lasciando intendere che una copertura sul modello del Pontiac Silverdome statunitense possa essere più di un’ipotesi. Ma è tuttavia la struttura stessa dei catini nazionali in cemento a non rispondere da tempo alle più elementari e moderne istanze di utilizzo ergonomico lungo tutta la settimana e non solo in occasione delle partite, dove già la pista d’atletica presente in tanti di essi limita la vicinanza così inglese fra atleti e pubblico pagante.
L’eccezione al momento, in attesa delle eterne smanie mercantili di Maurizio Zamparini tra Venezia e Palermo, è data dal solo Juventus Stadium, lungimirante progetto di cult building che — una volta a regime — permetterà ai sostenitori di ogni età di vivere un’esperienza immersiva nel mito secondo le sue accezioni storiche, iconografiche, tecnologiche e di consumo; senza contare la perfetta rispondenza degli spalti al dover essere funzionali alla visibilità globale e alla partecipazione più intensa che si alza dalle curve.
Ma cosa succede quando il presidente è egli stesso un ultrà? Lampante il caso-Cagliari, il cui lìder maximo Cellino ha sfidato i divieti della prefettura all’afflusso di pubblico per il match contro la Roma, nel nuovo impianto di Is Arenas a Quartu Sant’Elena: più che il 3-0 a tavolino subìto dalla squadra sarda, duole la leggerezza con cui vengano favorite iniziative che prescindano dalla partecipazione degli spettatori in carne e ossa (lo stesso Cagliari ha traslocato nella lontanissima Trieste sul finire dello scorso campionato), quasi auspicando le porte chiuse e la monocrazia di Sky per evitare guai ravvisabili solo nella mente poco duttile dei tanti piccoli Cellino di paese.
Stride la fastosa cerimonia che il Celtic Park, la tana dei cattolici di Glasgow, ha da pochissimo tributato ai 125 anni del club colorando tutte e quattro i settori di biancoverde: oggi in Italia la disfida tra opposti sbandieratori si è spostata dagli annunci naif sui magazine come Supertifo ai clip di Youtube e ai loro minacciosi commenti hard boiled. Per togliere il telecomando agli Ivan Bogdanov di mamma che hanno preso a fischiare pure i minuti di silenzio prepartita, forse bisognerà sperare in una palingenesi brasiliana: i mondiali del 2014 e le Olimpiadi due anni più tardi consegneranno a Rio de Janeiro e all’impetuosa crescita del gigante sudamericano la chance planetaria di riportare l’identità, il colore, l’umanità e pure la follia al giusto ruolo che compete loro nel calcio. ★