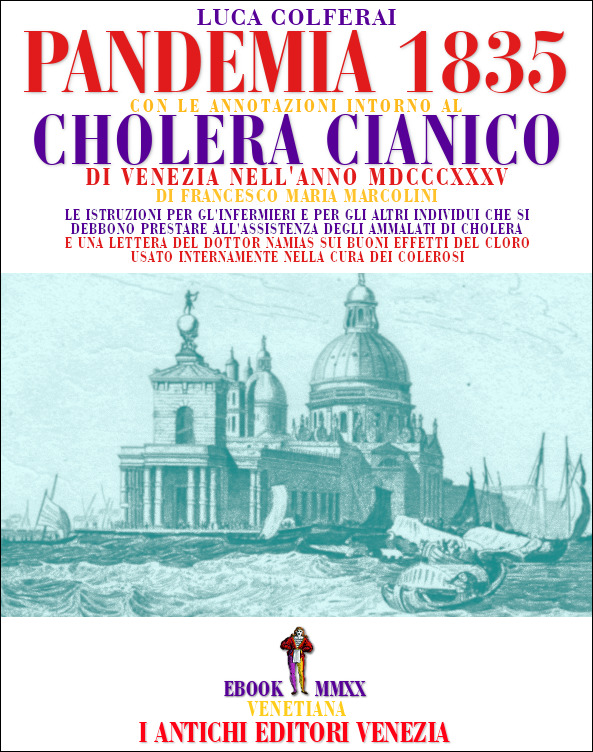La rucola
sul tetto
Anteprima sulla scena gastronomica di Brooklyn
A passeggio tra le nuove tendenze gastronomiche di New York. Tra moda, ossessione ed eterni ritorni generazionali una mappa del gusto e delle manie più in voga a Long Island.
NEW YORK — Se volete avere una chiara immagine della scena gastronomica a Brooklyn, come se foste seduti in prima fila e al centro, dovete assolutamente andare da Roberta’s. Entrare nella sala principale sembra più che altro di osservare una collezione scombinata di tavoli grezzi e sedie spaiate disposte alla meno peggio attorno ad un grande forno a legna per la pizza. A lato, in uno spazio vuoto, alcuni tavolini da picnic sotto un telo di plastica. Un capanno funge da consolle per dj da cui vengono sparati i programmi di Heritage Radio Network, che è una sorta di garbato canale di propaganda slow-food.
Ma se guardate al soffitto, ecco che vi appare un’altra caratteristica peculiare del ristorante, totalmente inaspettata: una serie di serre pensili improvvisate arrangiate sul tetto. Roberta’s porta il mantra del movimento slow food «mangia locale» ad altezze inaspettate: l’insalata che avete nel piatto è raccolta proprio sopra la vostra testa.
La cosa suona ancora più strana se considerate il grigiore del circondario. Il ristorante è situato a Bushwick, un quartiere che fino a vent’anni fa era considerato il più mortale della città, allora al top della classifica mondiale delle città infestate dal crimine. Il distretto è disseminato di case popolari e magazzini, che qui hanno indifferentemente l’aspetto di scatoloni a due piani. Ma gli affitti sono bassi e, a New York, l’economia immobiliare è l’unica cosa che conti. Così, se volete cominciare a capire il fenomeno Brooklyn food, il mercato degli immobili è sicuramente la prima cosa da considerare.
New York, lo spiego per chi non ha un’intima conoscenza dei ponti e dei tunnel della città, e più ancora delle sue strutture sociali, consiste di cinque sobborghi.
Manhattan è al top nelle cartoline, e se siete uno sceicco petrolifico o uno spietato oligarca russo, è sicuramente qui che vorrete istituire la vostra sede operativa. Nel corso degli anni Novanta quel poco che rimaneva di marginale (nel senso di accessibile ai comuni mortali) nel circondario è stato divorato da immensi condomini e da costosissimi ristoranti a tema. Tutta la variegata umanità dedita alla creatività e all’arte, necessitata anch’essa di un posto dove vivere e lavorare, si trasferì quindi a Williamsburg e altre zone circonvicine, a Brooklyn, nella punta sud-occidentale dell’isola di Long Island. E inevitabilmente una grossa fetta di gioventù di belle speranze la seguì — costringendo parte dei creativi ad un’altra forzata migrazione cittadina — portandosi dietro inevitabilmente bar, ristoranti, caffè e formaggierie alla moda (nei collegamenti l’itinerario culinario di Williamsburg). Ed ecco Brooklyn diventata trendy.
È un fenomeno comune e frequente in tutte le città. Era quello che era successo anche a Manhattan, prima; ma nel caso di Brooklyn il fenomeno ha preso delle caratteristiche differenti. Forse sarà a causa dello zeitgeist gastronomico (lo spirito dei tempi alimentare, diciamo così) dei primi anni del millennio; e forse a causa dell’incremento demografico della Generazione Y (i figli dei figli del baby-boom degli anni Sessanta) ma Brooklyn non ha seguito il solito schema di trasformazione in quartiere figo.
Negli Stati Uniti, il movimento slow-food e la ricchezza dorata della prima metà degli anni duemila hanno creato le condizioni per cui alcuni (ovviamente di una certa classe sociale) possono ricercare il massimo della qualità nel cibo senza preoccuparsi del prezzo da pagare. Ciò, dall’altra parte, ha favorito una nuova tipologia di artigiani dell’alimentazione in grado di offrire ogni sorta di prodotti, dal formaggio a settantacinque dollari al chilo alla bottiglia di whisky da centocinquanta (e tenete conto che i prezzi degli alimentari di massa qui sono generalmente molto più bassi che nella vecchia Europa). Molti di questi, consumatori e produttori, sono giovani, tutti sono fanatici. A New York si sono riuniti a Brooklyn.
Il Movimento Gourmet di Brooklyn (se mi è concesso chiamarlo così) ha sicuramente caratteristiche in parte generazionali. La maggior parte dei suoi componenti è figlia dei baby-boomer e inevitabilmente ne condivide la tendenza all’idealismo e alla vanità. C’è sempre un’aria da comune hippy attorno alle boutique alimentari di Brooklyn, anche se molti dei comunardi hanno tutto l’aspetto di chi vive di fondi fiduciari. Anche se, disgraziatamente, è rimasto un tocco alla Woodstock nelle cure personali: molti sfoggiano barbe foltissime adatte agli alpestri cacciatori del zone più selvagge del Montana.
A Brooklyn ci sono due parole magiche: locale e artigianale. Detta così pare comprensibile, ma per un europeo devo dare una piccola aggiunta interpretativa. Locale non significa solo che in ristorante la rucola cresce sopra le vostre teste; può anche significare del grano maturato e mietuto sempre nello Stato di New York, ma a trecento chilometri da Brooklyn. Artigianale non significa creato secondo uno stile e una tradizione locali tramandati da generazioni; ma fatto a mano in piccole quantità e molto carino. Così i cioccolatini Tumbador, nella zona di Red Hook a Brooklyn, creano versioni artigianali degli snack industriali.
E poi ci sono le manie. Ossessioni direi.
Come il caffè. Il caffè deve assolutamente essere sostenibile, deve essere tostato artigianalmente, e preparato con una macchina che sia almeno elegante; o colato singolarmente tazza per tazza, che è l’ultima moda. Ciò indipendentemente dal fatto che alla fine viene sempre servito dentro un bicchierone di carta con il coperchio di plastica semitrasparente, il tutto usa e getta.
Come i cocktail. Preparati con tequila o white whisky — whisky non invecchiato, cioè una specie di vodka — da cento dollari alla bottiglia, mischiati con speciali infusi di erbe ed estratti di frutta. Invariabilmente e indistinguibilmente dolcissimi e decisamente stucchevoli (almeno secondo il mio gusto). Così i barman diventano delle piccole celebrità. L’altro giorno un cartello annunciava a caratteri cubitali un «barista di fama mondiale» ospite la prossima settimana. Per una delle tante bizzarrie linguistiche dei prestiti e dei calchi — anche gli anglofoni hanno questa mania di sbagliare le parole prese in prestito dalle altre lingue — «barista» qui significa chi fa il caffè, che ad essere pignoli in italiano si dice «banchista» (il barista fa invece i cocktail).
L’altra mania compulsiva del momento, forse per la risonanza decisamente macho che attrae inesorabilmente i giovani maschi barbuti o dotati di ormoni esuberanti, è la macelleria fai da te. A Williamsburg furoreggia Meat Hook (il gancio da macellaio) nato come un’associazione improvvisata di giovani dediti alla trasformazione di interi suini in costolette e salsicce ed ora divenuto una vera e propria scuola di cucina dove uomini e donne possono imparare a preparare praticamente di tutto, dai sottaceti alle salsicce. Ancora una volta aleggia inconfondibile lo spirito alternativo e autosufficiente dell’era hippy e il ricordo del «pensa in grande agisci in piccolo» del mitico Whole Earth Catalog di Stewart Brand (lo stesso da cui Steve Jobs copiò il suo celebre «Stay hungry, stay foolish» ma questa è un’altra storia).
C’è, in tutto ciò, qualcosa di indiscutibilmente prezioso, sanamente ingenuo, ma anche di vacuo e pretenzioso. Un po’ come una ragazzina che ha appena imparato a truccarsi. Un entusiasmo giovanile che può essere contagioso, e anche pericoloso. Però, sul serio, la pizza di Roberta’s è veramente buona e la rucola coltivata sul tetto è deliziosamente fresca. ●
(traduzione e adattamento di Luca Colferai)