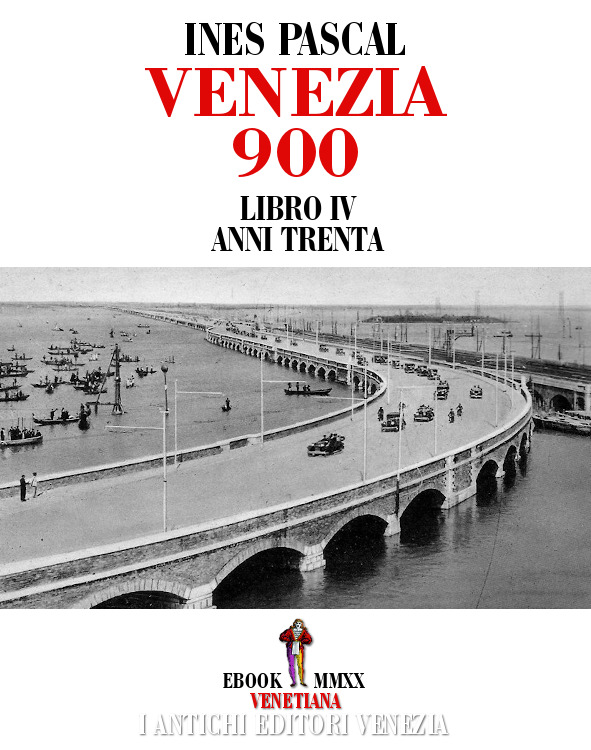Il verdetto
Il verdetto è il giudizio espresso da una giuria secondariamente ad un capo d’imputazione. Una, due, o più persone vengono giudicate per quello che hanno fatto o detto. Quando gli imputati sono in numero superiore a uno, i «colpevoli» tendono ad accusarsi a vicenda creando incomprensione nei giudicanti. Il verdetto è un giudizio di assoluzione o colpevolezza. Il verdetto è quindi un giudizio espresso perché richiesto, e nel rispetto delle leggi, ma è anche il giudizio del popolo non chiamato a giudicare. Per effetto di un verdetto assumiamo il ruolo, che non abbiamo volutamente assunto, di assolto o colpevole. Giudicati, affrontiamo diversi percorsi che cambieranno il nostro modo di approcciare la vita.
Tutti, anche coloro i quali siano per carattere immuni ai giudizi, saranno comunque volenti o nolenti sempre giudicati. Persino quando non ce ne sarà motivo, persino quando ci stiamo facendo gli affari nostri, ci sarà un qualcuno che probabilmente nemmeno conosciamo, pronto a giudicare il tuo atteggiamento. Mi ricordo di quando ero bambino e già allora si percepiva la sensazione di essere tutti schedati, tutti controllati. Ricordo i primi film di spionaggio, e quel mondo che allora sembrava surreale è diventato realtà. Cimici, intercettazioni telefoniche, quelle che permettono al detective di scoprire l’assassino in due minuti, fanno ridere rispetto alla realtà dei nostri giorni. Ogni parola è ascoltata, elaborata e giudicata, ma questi sono solo dettagli nel grande mare. Dietro ogni verdetto, però, bisogna ricordarsi che deve esserci il ragionevole dubbio!!!
Frequentavo la lavanderia a gettoni perché, dopo il divorzio, mi ero lasciato un po’ andare, e avevo cominciato ad assumere abitudini costanti e ripetute, come fare la colazione al vecchio Bar Turriga, pranzare all’Osteria dei Naufraghi, andare agli incontri per alcolizzati pur essendo astemio, e anche fare, come avevo già anticipato, la lavatrice all’incrocio di Via Zonicchia vicino al punto di incontro serale al Bar Omnibus, per il solito aperitivo degli spritzomani del luogo. L’unica cosa che mi ero portato dietro in tutti gli anni della mia esistenza, dopo essermi lasciato alle spalle un passato di vita normale, di marito, di padre e di lavoratore, era quella curiosità ostinata di ascoltare e guardare i dettagli.
Seduto sulla panchina all’interno della lavanderia alternavo lo sguardo all’obló, e mi ipnotizzavo guardando gli indumenti girare nel cestello. Poi giravo la testa rivolgendo lo sguardo al Bar Omnibus, guardando il brulicare e susseguirsi di persone che sghignazzavano, brindavano e sorridevano consumando al bar. Ben presto imparai a suddividere le immagini degli indumenti che rotolavano dietro quell’oblò, dalle immagini riflesse dal vetro dell’oblò stesso. Era ben presto diventato un gioco che mi permetteva di passare dal trans indotto dal continuo rotolare degli indumenti, alle immagini che provenivano dal vicino bar, distorte per effetto della concavità del vetro dell’oblò.
Non serviva più girarsi e separare le due cose. Praticamente, andavo e venivo dallo stato di trans a quello di lettore psichedelico degli eventi e degli accadimenti che si riflettevano in modo confuso, proprio come accade alla propria immagine specchiata nel laghetto, rotta dai cerchi concentrici di quel sasso che non è stato in grado di distruggere la propria immagine, ma solo distorcerla per poi vederla pian piano ricomparire a cavallo delle sinuose ondulazioni. Era diventato il mio divertimento maggiore, il massimo dello sballo, perché il passare da un piano a un altro di quell’oblò, pur trattandosi solo di pochi centimetri, ricreava situazioni e soprattutto sensazioni contraddittorie.
Quel trans ipnotico del cestello rotolante amplificava la distorsione delle cose e delle persone riflesse. Ma un giorno accadde qualcosa. Accadde che vidi, chiaramente, e con colori vividi, l’arancione dell’Aperol mescolarsi al sangue di una mano insanguinata dai pezzi di vetro stretti nel pugno. A quel punto mi girai di scatto per guardare attraverso la vetrina della lavanderia, per vedere in modo diretto e senza riflessi, cosa veramente stesse succedendo al Bar Omnibus. Non vidi nulla di strano, scrollai il capo come per volermi svegliare da quel torpore, e riguardai, ma non vidi nulla che ricordasse quello che avevo appena visto nell’oblò.
Un brivido freddo mi percorse la schiena, poggiai i gomiti sulle ginocchia, e presi la testa tra le mani facendo scorrere i capelli tra le dita. Chiusi gli occhi, perché la testa pulsava, e strinsi forte col palmo delle mani sulle tempie fino a quando, quasi procurandomi dolore fisico, riuscii a cancellare il ricordo di quella sensazione. Turbato, raccolsi gli indumenti dalla lavatrice e mi diressi a casa, dove ad aspettarmi c’era il silenzio della mia stanza. Mi distesi sul divano e mi misi a guardare il soffitto bianco. L’immagine dell’arancione e del sangue che usciva da quel pugno chiuso che stringeva i cocci di vetro non mi voleva abbandonare. Anche se non rappresentava, in realtà, una visione così terrificante, quell’immagine prese possesso di me, e contemporaneamente iniziai a percepire una strana sensazione di oppressione al petto. Non avevo il battito accelerato né respiravo affannosamente. Semplicemente provavo questo disagio.
Non vi diedi troppo peso e ci dormii sopra. Il giorno seguente ripresi la mia routine con colazione al Bar Turriga, dove più che leggere le notizie sul giornale, mi limitavo a guardare l’oroscopo, leggendolo anche ai vecchietti che ormai avevano fatto, di questa abitudine, un rito. Quel giorno non avevo indumenti da lavare, ma mi recai ugualmente alla lavanderia di Via Zonicchia, tanto sapevo che era sempre in funzione qualche lavatrice, anche se la mia preferita era la prima, quella appena entrati sulla destra, perché era l’unica che mi permetteva di tenere sott’occhio il tran tran dell’andirivieni delle persone al Bar Omnibus senza dover girare la testa, e quindi mostrare la mia curiosità.
Non dovetti aspettare molto prima che qualcuno entrasse e prendesse possesso della lavatrice. Io ero seduto lì, sulla panchina, davanti all’oblò, aspettando solo che il mio sguardo venisse catturato da quel rotolare, per poter cadere in trans. Provai, e con un po’ di apprensione, il giochino di sfochettare per passare dall’immagine all’interno dell’oblò, a quella riflessa. Per riuscirci, bisognava fare come in quell’esercizio semplice che consiste nel disegnare due punti vicini su di un pezzo di carta ed avvicinarli agli occhi fino a che appaiano come un’unica cosa. Le immagini riflesse dalla concavità dell’oblò apparivano distorte come era logico aspettarsi, i corpi fermi assumevano quelle forme allungate o allargate tipiche degli specchi magici delle giostre, mentre le persone in movimento riflettevano solo la mescolanza di colori ai quali era difficile attribuire una immagine concreta. Non rimasi a lungo, e mi lasciai trasportare da quel gioco di colori e dalla musica della filodiffusione che dagli altoparlanti copriva il rumore delle lavatrici.
È vero, non rimasi a lungo, è vero che non si rimaterializzarono nuove immagini di sangue, ma l’oppressione al petto era sempre presente. Stavo per alzarmi, girai la testa a destra, verso la porta, quando ancora le ginocchia erano piegate, lo sguardo stava abbandonando l’oblò, ma l’occhio sinistro rimase paralizzato dal lato della lavatrice: l’immagine di bufali inferociti che si scagliavano contro un bambino, impressionarono la retina di quell’occhio come in una pellicola fotografica. Incredulo e spaesato, in mezzo a una landa deserta, il bambino sembrava stesse aspettando, impassibile, di essere travolto. Il vapore si condensava fuori dalle narici dei bufali mentre avanzavano inesorabili verso quello scontro inevitabile. Il tutto si mescolava con la polvere sabbiosa sollevata dagli unghioni di quella mandria inferocita, che sembrava quasi smaterializzarsi dietro quel nuvolone, mentre di loro si vedeva solo l’enorme capo. Più avanzavano, più la mia angoscia cresceva, e poco prima dell’impatto riuscii a strappare l’occhio da quella visione agghiacciante.
Ero ancora curvo sulla schiena con le gambe semi flesse. Mi raddrizzai di colpo. Scosso, visibilmente scosso, volli ricontrollare la lavatrice, che però mostrò solo il suo essere elettrodomestico. Allora mi rigirai e imboccai l’uscita, ma appena fuori mi dovetti appoggiare alla prima colonna del sottoportico, perché fui colto da conati di vomito incoercibili. Tutti giustamente mi schivavano, non era un bel vedere. E io, già di mio schivo, ero fortemente imbarazzato da quella situazione, ma non potevo farci nulla. Fui avvicinato da una gentile signora che, incurante del mio aspetto, mi porse dei fazzolettini di carta e si rassicurò sulle mie condizioni prima di accomiatarsi. Piano piano recuperai energia, e mi diressi verso casa. Mi gettai sul letto vestito, con la boule dell’acqua calda preparata in velocità. L’appoggiai sulla pancia per provare ad alleviare la tensione. Quel giorno non sarei certamente potuto andare alla riunione con gli alcolisti anonimi.
Non capivo come mai quelle immagini mi avessero colpito così profondamente. Probabilmente, anzi sicuramente, erano frutto della mia immaginazione, ma l’ansia invece che calare si impennò, costringendomi a usare quelle malefiche pillole che ormai avevo abbandonato da anni. Mi addormentai in poco tempo, e mi risvegliai il giorno dopo con il cuscino bagnato, come se avessi dormito con la bocca aperta e avessi lascito cadere la bavetta. Mi sentivo bene e riposato, ma non volli pensare a quanto vissuto i giorni precedenti, ma come sapete bene anche voi, la lingua batte dove il dente duole, esattamente come fa la mente quando le dici di non pensare. Invece pensai, e realizzai che l’unico modo per distrarmi fosse quello di uscire. Mi diressi allora al Bar Turriga, a scherzare sugli oroscopi con i miei amici vecchietti, e mi trattenni fino quasi l’ora di pranzo, perché non volevo pensare.
Da lì mi diressi all’Osteria dei Naufraghi, dove mi concessi un buon piatto di baccalà mantecato e un buon risotto di pesce. Erano ormai le tre del pomeriggio, e più cercavo di allontanare i pensieri dagli accadimenti vissuti alla lavanderia di Via Zonicchia, più questi venivano a galla trasportati dalla corrente della curiosità. Ma quel giorno tenni fede alla mia promessa di non andare in lavanderia, e mi diressi alla riunione con gli alcolisti anonimi. Nonostante non avessi avuto problemi di alcol in passato,
mi era stato concesso di recarmi alle sedute grazie al fatto che ero amico del dottor Ermanno Gallinari, che oltre a essere amico mio e di famiglia, da bravo psicologo mi aveva anche aiutato anni addietro quando mi separai. Però Ermanno doveva giustificare la mia presenza nel gruppo, quindi disse che ero lì per aiutare un amico che non voleva, o non aveva la forza di volontà, di partecipare a quelle sedute.
Come al solito, ognuno riportava i propri progressi e le difficoltà incontrate durante la settimana, ma aleggiava quel clima meschino di falso perbenismo, perché tutti erano consapevoli di quante menzogne si stessero raccontando. Si percepiva l’aria del raziocinio imprigionare la debolezza, mentre il compito di Ermanno era quello di autoconvincerli che quel malessere fosse il frutto dell’alcol e non del loro malessere interiore. Beh, quel giorno mi sentivo come loro, imprigionato nelle mie debolezze e nelle mie paure. Antonio ammise di non essere riuscito a mantenere il digiuno alcolico quella settimana. Rischiava l’espulsione per quella debolezza raccontata con apparente serenità. Rebecca si alzò di scatto e additandolo gli disse: non puoi più stare qui, sei un debole, sei la vergogna del gruppo. E scoppiò a piangere.
Non capivo se avesse pianto per le aspettative che aveva riposto in Antonio. O forse ne era innamorata? Oppure quel pianto era lo sfogo per la frustrazione di aver visto in quel gesto la forza di aver ammesso la propria debolezza, forza che lei sapeva di non avere e che condizionava tutta la sua esistenza. In un attimo Rebecca passò da giudicante all’essere giudicata. Lei era persino arrivata al verdetto. E alla condanna. Ma quel pianto le fu fatale. Antonio da trasgressore divenne eroe, mentre Rebecca, agli occhi della maggior parte dei partecipanti, apparve invece come la cattiva. Ermanno non poté a quel punto non espellere Antonio, nel rispetto delle regole. Antonio, sereno e con un bel sorriso, abbracciò tutti uno per uno, compresa Rebecca, e allontanandosi ringraziò Ermanno. Guardandolo negli occhi gli disse: «un conto è bere perché ne hai voglia, un conto è farlo perché non puoi farne a meno. Finalmente ho capito che stavo mentendo a me stesso».
Un giudizio non dovrebbe influenzare o minare le nostre sicurezze, ma non fu così per Rebecca, che da giudicante passò dalla parte dell’essere giudicata, forse per l’ennesima volta. Rebecca aveva imparato a giudicare, giudicare e giudicare gli altri compulsivamente. Puntava sempre il dito, argomentando con presunta consapevolezza e obiettività, ma le sue parole portavano con sé il marcio della voglia di ferire, di condannare. Aveva imparato da sua madre, anche lei meschinamente invadente, pronta a ferire, e capace di giocare sui sensi di colpa per ottenere i propri risultati. Così Rebecca cercava di imbavagliare il mondo strillando più forte di lui, ma rimase imprigionata nelle sue fragilità. Parlai anch’io quel giorno, anche se normalmente ascoltavo solo ed in silenzio, ma non riuscivo a stare zitto.
Egoisticamente raccontai ciò che mi era capitato, incurante delle loro problematiche, arrogandomi il diritto di parlare nonostante non ne avessi diritto. Raccontai ogni dettaglio di quell’angoscia, e persino il dottore mi guardò sbigottito. Troppe cose erano e stavano succedendo quel giorno, l’incontro stava per volgere al termine e nessuno aveva più voglia di parlare. Attoniti e in silenzio, come dei bambini sgridati a scuola, a testa bassa ci accomiatammo dandoci appuntamento per la settimana successiva. Per tre giorni non uscii di casa. Cercavo protezione nell’unico posto che credevo potesse darmela, per accorgermi ora dopo ora che non potevo fuggire al mio destino, e che, inevitabilmente, avrei dovuto rimboccarmi le maniche per riaffrontare ciò che avevo lasciato in sospeso.
Stessa ora, stesso luogo, stessa lavanderia. Non fu facile entrare, guardavo al Bar Omnibus e alla porta d’ingresso della lavanderia, guardavo già quell’oblò che girava, ma non riuscivo a trovare la forza per oltrepassare quella porta e sedermi di fronte alla lavatrice. Lasciai che almeno tre, quattro persone, finissero il loro bucato, mi sentivo come un barbone pronto per fare una stupida rapina, perché sicuramente era quella l’impressione che potevo trasmettere ai passanti. Quindi, tra l’imbarazzo e la voglia di risolvere la questione, decisi di entrare e sedermi lì in santa concentrazione. Con le gambe un po’ tremolanti, entrai e presi posto sulla mia panchina, sfidai quell’oblò come se fosse la macchina del male, e mi preparai con la respirazione diaframmatica a entrare di nuovo in quella spirale d’angoscia.
Inspiravo profondamente, fino a gonfiare l’addome, per poi lasciar uscire tutta l’aria senza resistenze, fino a contrarre gli addominali. Continuai così per alcuni minuti, e tra l’iperossigenazione e il trans da cestello, quasi persi conoscenza. In breve apparve una donna bellissima che camminava nuda verso un uomo dal cappotto nero che le andava incontro. Io di lui potevo vedere solo la schiena, ma avevo la sensazione che potevo essere io quell’uomo, quindi le sensazioni che percepivo da quel vedere erano rasserenanti. Anche se era molto distante, lei assomigliava in tutto alla mia bellissima moglie. Ne ero quasi sicuro, e lo fui concretamente quando riuscii a metterla bene a fuoco. Il suo sorriso era accattivante, seducente. Stavo per andarle incontro, quando mi accorsi che il suo sguardo non era rivolto verso di me. Allora girai di scatto la testa per guardarmi intorno, e mi accorsi di essere seguito da un esercito di simil cloni, tutti uguali, tutti con il lungo cappotto nero.
La riguardai nel suo smagliante sorriso, ma il suo sguardo era rivolto altrove, non verso di me, io di mio continuavo ad andarle incontro incredulo per quello che vedevo, ma il panico sopraggiunse quando mi trovai intrappolato nel fango che, piano piano, mi inghiottiva all’insaputa del suo sguardo catturato da chissà quale clone. La rabbia che cresceva in me per essermi sentito escluso dalla sua vita, immediatamente lasciò il posto alla voglia di sopravvivenza, e la mia attenzione si spostò alla ricerca di un’ancora di salvataggio. Qualsiasi appiglio era buono. La sensazione di essere imprigionato nel fango che mi stringeva togliendomi il respiro, e che piano piano stava per ingoiare il mio corpo, mi distolse completamente dalla rabbia che avevo dentro. Trovai l’ossigeno necessario per salvarmi, nel silenzio della mia disperazione, rilassandomi. Mi aggrappai alla prima cosa utile a non farmi sprofondare, e mi accorsi di quante possibilità avevo.
Vennero in soccorso tirandomi per le braccia, e io mi aggrappai con tutta la forza per non affondare. Non scoppiai a piangere di gioia, non scoppiai a piangere di tristezza, e ritrovai persino mia moglie, quasi incredula, un po’ dimessa e in disparte, pronta ad aiutarmi a rialzarmi. Ma chi dovevo ringraziare e/o colpevolizzare per quanto era accaduto? Probabilmente me stesso.
Avevo fatto tutto io: il sangue mescolato ai cocci di vetro a indicare la rabbia, il bambino a rappresentare la mia fragilità, e infine questo epilogo a mostrare come dei giudizi errati possano condurre a un verdetto sbagliato che condizionerà forse e per sempre il tuo futuro.★