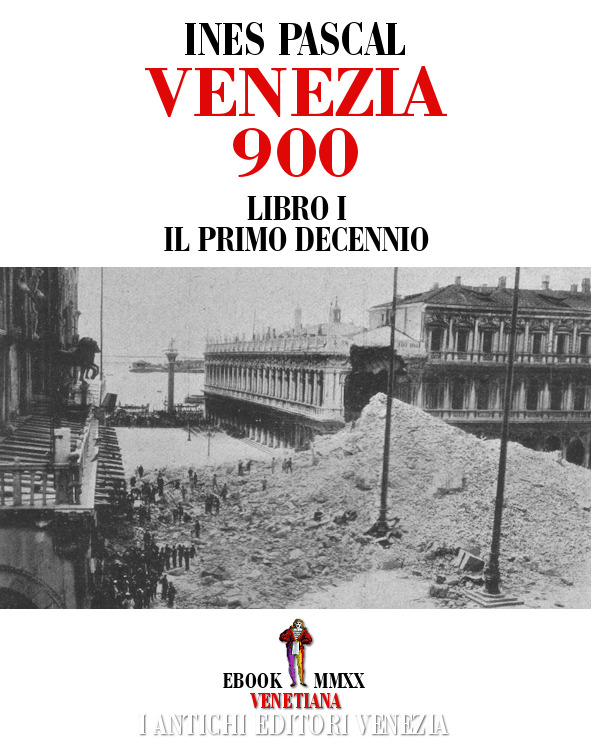L’anno più difficile
della mia vita
Il trench di Chloé — Capitolo I
Chloé è una psicologa francese in vacanza forzata a Venezia. Alla soglia dei trent’anni con un rapporto di convivenza tormentato con Philippe, il suo lui trombettista freelance itinerante, era arrivata a un bivio: la libera professione o il dottorato di ricerca a Venezia. Aveva già capito che la sua storia era al capolinea, ma non voleva limitarsi a cambiare trucco e parrucco e buttare tutto alle ortiche…
Lei, in buona fede e come fanno la maggior parte delle ragazze, ci aveva già provato: capello nero corvino, taglio carré e rossetto rosso Chanel senza però sortire nessun effetto, quindi, con il nuovo look e un po’ di leggerezza, accettò il dottorato partendo per Venezia.
Macchina no, aereo nemmeno, bus mi sa da gita geriatrica, ed eccomi approdare a Venezia Santa Lucia, stazione ferroviaria.
Era la prima volta che ci venivo ed ero persino prevenuta, forse più che prevenuta, ero delusa e incazzata.
A Venezia, così come a Parigi, se non si è adolescenti in gita scolastica si deve andare in coppia, dunque dovevo prepararmi psicologicamente e fuori dei binari, con il mio piccolo trolley, incominciai a guardarmi attorno per cercare un’ancora emozionale.
Dieci metri e oops, trovata: Gelateria internazionale Grom.
Cono al gusto croccantino, tanta panna, cintura del trench allacciata in vita, occhiale Gucci dalla importante montatura nera, due leccatine di gelato e via, ero pronta ad affrontare la città.
Di certo, così conciata, non passavo inosservata e da psicologa avrei dovuto domandarmi: Mi sento come se dovessi sprofondare in un baratro, ho il morale a pezzi, eppure… Beh, ho capito! Non era così difficile. Sto giocando di rimessa e in difesa perché non voglio porgere metaforicamente l’altra guancia, quindi, è giusto che tutti mi vedano splendida splendente.
Devo andare al ghetto, mi hanno detto che è vicino alla stazione.
Ho affittato una stanza in un piccolo appartamento che dovrei dividere con due studenti.
Ma sono nuovamente in crisi, perché nonostante sia super intelligente, qui a Venezia non ce la si può fare, trovare un civico è come vincere la lotteria.
Ok, chiedo aiuto e il mio secondo contatto dopo l’internazionale gelato Grom è il primo passante dal quale ottenere informazioni.
Ho fermato 10 persone tra francesi, inglesi, tedeschi ecc., ecc.: mi fermo, il perché l’avete già intuito. Non sono stupida, l’ho già detto, ma anche i negozianti erano stranieri, ma non stranieri come quelli che abbiamo in Francia, che sono più francesi di noi: no, no qui il veneziano di città è cosa rara.
Sapevo che dovevo stare alla larga dai gondolieri, ma pensavo fosse per il solito motivo delle avance.
Di certo io non le temevo e mi sono avvicinata al pontiletto scivoloso.
Un bel ragazzo, quasi starnazzando urlandomi cose incomprensibili, mi stava venendo incontro facendo dei gestacci con le mani: era chiaro, ma solo per me, che ci stava provando.
No, mi sbagliavo, stava avvisandomi che non dovevo montare su quel pontile e l’indomani ero in prima pagina con il titolo «Turista francese finisce in Canal grande, moto ondoso sotto accusa».
Onestamente, è stata colpa mia: la passerella era al pelo dell’acqua, è passata una barca, l’onda stava per bagnarmi, mi sono messa in punta di piedi e in un attimo mi sono ritrovata a far gambe a bordo piscina.
Comunque, dopo l’ospedale, la caserma della polizia ecc., almeno mi hanno portato a casa.
Non c’era nessuno ad attendermi, ma ero sufficientemente in imbarazzo da liberare a forza i poliziotti che ormai, avendomi quasi adottato, si sentivano in obbligo di consegnarmi al destinatario.
Dovetti insistere e ci riuscii.
Passai un’ora seduta sui gradini di casa ed ero stranamente contenta, mi sentivo libera, forse direi meglio, lavata.
Finalmente, dopo aver chiesto a sette persone che stavano entrando: «Sei tu Federica?», l’ottava rispose: «Tu devi essere Chloé! Martina però dovrebbe essere già a casa da mezz’ora!»
A quell’affermazione, mi limitai a deglutire e quando entrai a casa e mi presentai alla ventenne Martina che avevo incrociato trenta minuti prima e che con serenità autistica mi aveva risposto: «No, non sono Federica!», dissi: «Ciao! Hai dei bei capelli, lo stesso colore dei miei».
In un attimo, mi ero riallineata al cannabis world adolescenziale.
Ero decisamente fuori luogo in quel l’appartamento, saranno state al secondo anno di Università.
Federica studiava lingue orientali, mentre Martina mi sembra studiasse chimica.
Comunque, non mi dilungo sul mio inserimento universitario, anche lì alti e bassi, avevo dovuto rivedere un po’ le mie abitudini, ma devo dire che ben presto incominciai a ridere, almeno dopo le 20.00 e dopo il secondo aperitivo.
Scusatemi, l’ho chiamato in modo non corretto.
Dopo il secondo, immancabile, corroborante, euforizzante, socializzante spritz all’Aperol.
Ormai ero perfettamente introdotta nel mondo universitario: povera in canna e con la vergogna di dover chiedere saltuariamente un aiuto a casa, ma serenamente e piacevolmente ubriaca la sera.
Così serena che incominciavo ad apprezzare la lentezza inesorabile di questa città che piano piano mi stava conquistando e forse anche imprigionando.
Le gite in barca, i tramonti, l’acqua, i canali, la biancheria stesa nelle calli, la storia e l’immancabile spritz mi avevano fatto dimenticare il mio stato di single, però ero alla continua ricerca di cose nuove da fare e il metodo migliore per farlo in una città universitaria era quello di divorarsi la bacheca degli annunci.
Praticamente ero diventata una frequentatrice compulsiva di bacheche e non perdevo, almeno inizialmente, nessun evento.
Dalla danza del ventre alla cena congolese, dalle musiche caucasiche al Pifferaio magico.
Ma quel giorno, la mia vita stava per prendere una nuova direzione.
Ancora non lo sapevo, ma dal momento in cui decisi di iscrivermi a quel corso di sommelier la mia vita cambiò radicalmente.
Già mio padre mi aveva fatto conoscere il vino e forse, involontariamente, era un modo per riportarlo vicino, ma quando conobbi Marco, o meglio, quando conobbi il mio Prof. di vino: beh beh beh…
Non riesco nemmeno a descriverlo, perché solo al pensiero mi emoziono. Avrà avuto il doppio della mia età, avrebbe potuto essere mio padre, ma mio padre non aveva quel culo, e credetemi se faccio fatica solo a dire culo senza eccitarmi.
Poi, parlava in modo così suadente che mi catapultò con tutto il suo sapere nel suo mondo e ne rimasi completamente frastornata.
Doccia fredda? Investita da un tir? Ipnosi? Mah!
Certo, l’argomento era interessante! No, non il culo! Tutto quel sapere sul vino, gli uvaggi, il terreno, i minerali, la raccolta, la scelta degli acini, la fermentazione carbonica, i profumi, insomma, tutto quel mondo incominciò ad affascinarmi a tal punto che tutte le volte che Marco roteava un bicchiere io me lo immaginavo a letto e tutte le volte che infilava il naso per inebriarsi del profumo di quel vino, io facevo lo stesso immaginandomi il suo, e la cosa assunse dell’imbarazzante quando dalla terza, vera, degustazione, incominciai letteralmente a bagnarmi e provare un doppio piacere, di palato e di palato!!!
Marco, credo avesse capito, anche se c’era poco da capire.
In effetti, credo avessero capito tutti. Non avevo nessun freno inibitorio e, letteralmente, gemevo ogniqualvolta infilavo il naso in quel bicchiere.
Tutto accadeva rapidamente: lo guardavo, incominciavo a roteare la coppa, infilavo il naso, inspiravo a pieni polmoni inclinando il balloon, lo riguardavo con la palpebra già a mezz’asta e come una balenottera in amore partivo con i miei canti.
In generale sono una poco vergognina e anche in quell’occasione non provai vergogna se non quando Marco, il mio Prof., si avvicinò dicendomi: «Signorina, qual è il suo nome?». «Chloé», risposi, arrossendo all’improvviso.
«È la prima volta in carriera che qualcuno ha aggiunto qualcosa di concreto a quello che cerco di trasmettere. Grazie!»
Praticamente mi aveva stesa, io ormai non ero più normalmente rossa, ero piuttosto di color amaranto.
Seguì un harakiri metaforico che ho dovuto ripetere almeno tre volte prima di svenire finalmente tra le sue braccia.
Ricordo solo che al mio risveglio ero distesa su di un tavolo e tutti mi guardavano, con il vino che roteava nei loro bicchieri.
Sembrava stessero celebrando un rito satanico e io lì a fare la vittima sacrificale. In realtà, a loro interessava solo bere e il mio risveglio fu l’ennesimo ottimo motivo per brindare.
Il giorno successivo lo passai a letto.
Scuri chiusi, porta chiusa, luce principale spenta, fazzoletto in testa e un unico chiodo fisso: Marco mi chiamerà? O è meglio che lo chiami io con il pretesto di scusarmi?
La Chloé psicologa era ormai stata colpita e affondata come nel gioco di battaglia navale: avevo perso tutto, anche la portaerei. C5 colpita e affondata.
Non era rimasto in me nemmeno un briciolo di dignità e verso le sei di sera, esausta per l’attesa vana, lo chiamai.
I numeri 349117234 sulla tastiera del cellulare erano diventati, per tutto il giorno, il circuito preferito del mio pollice e dopo 75 minuti di prove finalmente ero riuscita a fare la pole position.
Bypassiamo la parte che seguì la risposta, per dignità personale, e diciamo solo che il giorno seguente ero stata invitata a una degustazione col Prof. al ristorante le Carampane, ore 19.30, per una verticale di Merlot, punta di diamante della serata, il Merlot della casa vinicola Toscana “Castello di Ama”.
Tralasciamo anche tutto ciò che ne è derivato, dal momento della chiamata fino alle 19.25 del giorno successivo compreso: sbalzi d’umore, sensazioni di panico, scelta del look…, solo al pensiero di aver dovuto fare la doccia cinque volte di fila per togliere il profumo che ripetutamente non incontrava i miei gusti mi farebbe venir voglia di nascondere la testa sotto il cuscino e mettermi a urlare a squarciagola, ma non sarebbe stato nulla d’eccezionale, perché quando ho rotto con le unghie il quarto paio di collant non avevo altra alternativa se non quella.
Ero talmente euforica e dannatamente persa che mi era completamente sfuggito il significato dell’invito a quella serata. Per l’eccitazione non avevo messo a fuoco le parole di Marco: «Sarai l’ospite d’onore».
No, non era una sua avance!
Avete perfettamente intuito.
Il caro, esimio Prof. mi aveva invitato solo per mostrare ai partecipanti la quintessenza della degustazione: la balenottera urlatrice.
Fui presentata seriamente da Marco come la rivelazione dell’anno, la donna che — alla Ray Charles — sapeva esprimere con i movimenti del collo, del busto e le sue vocalizzazioni qualcosa che lui stesso definì il “quinto senso” del vino.
Mi sentivo offesa, svilita, amareggiata, ma soprattutto rischiavo di diventare un fenomeno da baraccone.
Decisi in quel momento, lì per lì, di fargliela pagare e improvvisai.
Non volevo sembrare una donna-oggetto e mi atteggiai come una postsessantottina incazzata e in corteo per la difesa del diritto all’aborto.
Incominciai in modo retorico puntando il dito sul fatto che la figura del sommelier fosse quasi esclusivamente appannaggio del mondo maschile, ma questo mio argomentare voleva essere solamente provocatorio, perché volevo attirare la loro attenzione.
Presi la prima bottiglia che mi capitò tra le mani, ne lessi incuriosita l’etichetta e assunsi un’espressione compiaciuta e di interesse. Contemporaneamente, e con lo stesso sguardo, mi girai verso Marco.
Presi il coltellino del cavatappi e liberai il sughero tagliando il cappuccio che copre il tappo, ma mi fermai di colpo per andare verso Marco, che mi guardava basito.
Gli appoggiai le mani al collo e gli tolsi la cravatta slacciando il primo bottone, poi ripresi la bottiglia, liberai completamente il collo dall’alluminio, la stappai, ne versai un bicchiere e ne sniffai i profumi in modo molto compito.
Non avevo finito il mio show, il messaggio stava per arrivare forte e chiaro, ma nei tempi previsti dal mio copione.
Ritornai da Marco, mi avvicinai al collo e inspirai profondamente, mentre con le mani gli slacciavo la camicia.
Nessuno osò fermarmi. Negli occhi di Marco si leggeva un misto di imbarazzo ed emozione. A quel punto, e per non trasformare la serata in un incontro a luci rosse, offrii a Marco un calice di quell’amabile e fruttato Traminer e, baciandolo con gli occhi, dissi: «Grazie, Prof. È la prima volta che bevo un bicchiere di vino con qualcuno che vorrei aggiungesse qualcosa al mio modo di bere: c’è quasi riuscito! Proviamo col Merlot?»
Terminata la farsa mi girai rivolgendomi ai partecipanti e dissi: «Bere un bicchiere di vino è un’esperienza dalle mille sfaccettature e quello che voleva dire Marco, invitandomi qui questa sera, era molto semplice.
Si può bere in modo viscerale e non perché il vino va giù nello stomaco, ma perché, se se ne capiscono a fondo tutte le radici d’appartenenza, l’esperienza che ne deriva può toccare corde emozionali che non vi aspettate nemmeno di avere.
Non prendetelo come un inno all’alcolismo, ma piuttosto come consiglio ad ascoltare meglio voi stessi».
A quel punto non potevo fermarmi e continuare la serata con loro. Aspettai l’arrivo dei primi ‘cicchetti’, mi assicurai che i partecipanti fossero distratti e me ne andai stringendo in vita la cintura del mio inseparabile trench e ripassandomi le labbra di rosso Chanel.
Ero confusa, orgogliosa per essere riuscita a rovesciare la situazione a mio favore, ma svuotata perché in fondo mi sentivo amareggiata, e mentre espiravo forzatamente per liberarmi di quella tensione il suo braccio agganciò il mio, mi tirò di colpo e con una piroetta ci trovammo abbracciati come fossimo un’unica persona.
Marco non tentò nemmeno di baciarmi, reclinò dolcemente il capo, infilò dritto il naso sotto ai capelli e dietro l’orecchio e io feci lo stesso.
Rialzammo la testa come se stessimo uscendo da un minuto di immersione profonda nel quale ci eravamo scambiati mille emozioni.
Marco mi prese la mano e camminammo leggeri come due ragazzini per raggiungere la prima riva discreta dove sederci con i piedi a penzoloni a pelo dell’acqua del canale.
Tirò fuori due bicchieri, appoggiandoli sulla pietra d’Istria, e una bottiglia di fresco Verduzzo.
«Vorrei trovare la frase giusta per questo momento», mi disse.
«Vorrei farti capire quanto è importante per noi quello che stiamo facendo.
Vorrei potesse parlare il vino per me con tutta la sua poesia.
Vorrei farti capire quanto felice sono di averti incontrata.
Vorrei, vorrei, vorrei… vorrei essere il tuo vino», e scoppiò a piangere.
Aveva ancora la camicia aperta e il pelo brizzolato sul petto chiamò la mia mano.
Lo accarezzai in una dolce e lunga coccola, lui si lasciò lentamente cadere sulla schiena e cominciai a baciarlo tutto.
Fu intenso quel sentire e non avrei mai permesso che qualcosa potesse distrarmi dal quel magico momento.
Non stavamo tenendo conto di come sarebbe andata a finire quell’avventura ed era ovvio che nemmeno volevamo farlo.
La storia era cominciata in modo bizzarro e sembrava chiaro che entrambi volessimo tenere il treno su quei binari.
Con un po’ di difficoltà Marco si scosse da quel torpore, si mise in piedi, mi prese la mano dicendo: «Sono appena le 21.00, andiamo a mangiare qualcosa. Dai, seguimi!».
Civico 1492 Dorsoduro, un portoncino di legno si apriva su di una piccola corte dove semplici lampade in vetro soffiato, con la loro luce tenue, esaltavano la decadenza e il fascino della vera da pozzo circondata dal verde di quel giardino.
Come una bambina mi guardavo tutt’attorno e ogni più piccolo particolare attirava la mia attenzione.
Dai gradini consumati dal calpestio di chissà quanti milioni di piedi al glicine bianco che mai nessuno avrebbe minimamente ipotizzato di trovare dietro a un portone di una città così poco botanica.
Un piccolo paradiso nascosto, una nicchia dove ogni particolare lasciava libero spazio ai propri pensieri e fantasticherie, dove quelle pietre avrebbero potuto raccontare mille storie diverse.
Marco era già entrato a casa mentre io ancora vagavo per il giardino.
Lo chiamai a voce alta per capire dove sarei dovuta andare, ma non mi rispose.
Entrai di lì a poco nel piccolo attico, che mi accolse con delle bellissime travi a vista.
Lui stava già armeggiando in cucina, aveva scaraffato in un vecchio decanter un rosso dal color rubino, l’acqua era sul fuoco e si stava accingendo a imbastire la tavola.
Aveva un sorriso sornione e compiaciuto.
Appena entrata esordì con un «0ho, era ora! Ti eri persa?
Dai, scherzo!», disse, e aggiunse: «Ho una sorpresa per te!
La vedi quella bottiglia? È la prima che apro di un’unica cassa di 12 bottiglie battuta alla casa d’aste Sotheby’s di Londra.
Un dono della casa vinicola Sarda Argiolas a sua Maestà: trattasi di un vino particolare, è un blend di più uvaggi tra i quali non poteva mancare il Cannonau, ma devi sapere che queste 12 bottiglie sono le ultime rimaste al mondo, è per questo che hanno un valore inestimabile.
Ho fatto la follia di comprarle per due motivi: prima cosa, volevo che questo vino tornasse in Italia, ma soprattutto ci tenevo a finanziare un progetto umanitario di cui ti parlerò, ma non ora.
È un ottimo rosso questo Turriga, percepirai al palato i sapori dei minerali che si sono concentrati negli acini di queste viti cresciute su di un terreno sassoso e apprezzerai la freschezza del vento, del sole e della immensa terra sarda, che si libereranno in un sol boccato».
Mentre parlava, Marco stava già pelando le patate lesse, aveva allestito un tagliere con formaggi e marmellate varie e stava girando una frittatina ai bruscandoli.
«Lasciamo respirare ancora un po’ il vino», mi disse baciandomi delicatamente sulle labbra.
Era stupendo vederlo così sereno e coinvolto, ma era ancor più bello notare che vivevamo il nostro rapporto come se fossimo amici da un secolo, pur con la voglia e l’entusiasmo di due amanti novelli.
Il momento stava per arrivare, i calici roteavano, il vino liberava i suoi profumi, un piccolo brindisi e per un attimo fummo rapiti e fagocitati dal prezioso Turriga.
«Il vino è una esperienza dalle mille sfaccettature», dissi, poi lo guardai e parlai per l’ultima volta:
«Caro sommelier, è arrivato il tuo momento, d’ora in avanti tu sarai il mio vino e io la tua degustatrice».
Appoggiai il calice dopo averlo assaggiato nuovamente, mi misi alle spalle di Marco, lo presi per mano e lo portai a letto.
«Lasciati andare, lasciati gustare, lasciati annusare, dimenticati chi sei, ma sii te stesso, io sono pronta a fare del mio meglio per te, tu ricambiami se pensi ne stia valendo la pena».
Avevo voglia di scoprire quell’uomo proprio come si scopre un nuovo sapore, allo stesso modo volevo che lui vivesse l’esperienza di provare il desiderio di ricevere e dare come mai gli fosse capitato in vita. Mi immaginavo che il mio Marco avrebbe vissuto quel momento esattamente come avrebbe potuto farlo il nostro Turriga, cioè come un vino affinato in una botte per quattro anni, chiuso in una bottiglia e tenuto in vita per altri cinque anni da mani sapienti, finalmente liberato del tappo e pronto a regalarsi.
Fu una serata indimenticabile e, da quella, altre e altre ancora per un lungo periodo, ma non pensate che la convivenza con Marco sia stata facile.
Chiuso nel suo mondo e pieno di scudi a protezione della sua incolumità emotiva, si comportava in modo altalenante e dopo momenti di completa affettuosità era imbarazzante scoprire quanto potesse diventare distaccato e distante.
Era evidente che il nostro rapporto stava nascendo costellato da mille dubbi, e non mi riferisco alla serata che confermò quanto avevo già espresso, ma alle difficoltà che Marco aveva nel lasciarsi il passato alle spalle.
Due matrimoni e due figli, oltre agli irrisolti problemi psicologici che, a sua giustificazione, ognuno di noi si porta dentro.
Comunque sia, imparai a conoscere e apprezzare le sue virtù così come ad accettare i suoi down.
Inevitabilmente sposai la sua professione, ma per fortuna, grazie alle conoscenze di Marco, a tutto quello che mi aveva insegnato e anche alla mia caparbietà, riuscii a crearmi una piccola nicchia di mercato dove poter esprimere il mio talento.
(1-continua)