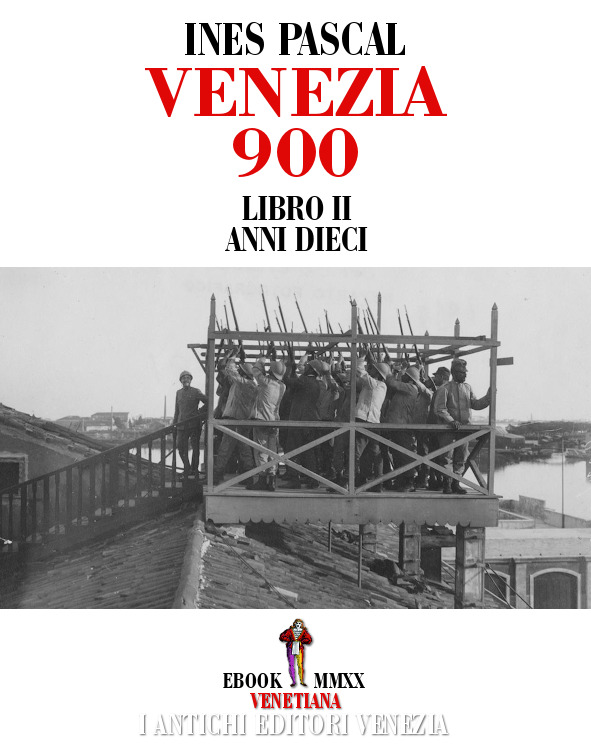Le ultime parole
di Orèade
Una ragazza hippy trascina il suo carrettino dalle piccole ruote nere. Il proprio materiale da lavoro è tenuto saldo da un gancetto ferma-oggetti, a molla.
Un momento che se ne va.
La gente continua a passare per Siniscola.
E continua a calpestare i ferrosi ponti che menano alla specola patavina; bagnati dalla pioggia.
Profumo di sigarette nel quartiere Brera, bar Jamaica. E una donna lombarda.
Una porta si apre in montagna, a giorno chiuso; i ladini sorridono festosi dopo aver trascorso il pomeriggio a fare all’amore nei boschi. Non più neve e crochi bianchi in sostituzione. Bosch d’Aurona. Bosch da Salejei. Bosch da Liviné.
Non ci sono più.
Due innamorati si rincorrono felici. Lui la ferma. La bacia. E le regala una rosa nera. Lei sgrana i grandi occhi blu. La ripone in un’agenda. L’appoggia sulla scrivania della sua cameretta. Da sotto alla porta di questa bigliettini dei suoi per farla zittire. E che si dicevano?
«Perché una rosa nera?»
«Perché sei bella come la notte che cade».
Tutto tace.
Verde smeraldo selvatico in una tela 80x100. Adrenalina. Voglia di pubbliche relazioni.
«Villa de Vecchi, villa de Vecchi: arrivo! Questo viaggio mi ha spossato».
Selva. Tre piani per riposare… Impendono dalle rettangolari viste edere stravaccate. Dietro fanno crocchio cipressi incombenti.
Al pianterreno la camera per me ospite. Appoggio la giacca sulla panca ai piedi del letto. Un catino per rinfrescarmi. Del sapone su un semicupio di zinco per lavarmi. Mi chiudo a chiave. Tento la maniglia. Mi spoglio.
La cupaggine è consegnata dappertutto. Odo versi di non so quali animali. I loro unghioli adunghiano prede che si dimenano gloglottanti.
«Si preparano per cosa?!»
…Esco dalla camera con in mano la vestaglia che indosso strada facendo. Salgo al primo piano, dove sono le camere da letto del Signore e parenti stretti.
C’è odore di chiuso. Di muffa. Interrompo una serie di starnuti sulla pedata di un gradino. Mi fermo. Ritorno sui miei passi dirigendomi verso l’uscita.
Dalla cucina afferro uno dei ferri del camino.
Sono fuori.
Un germano reale mi si fa dappresso. Mi dice che non avrò la mia «presentazione».
Chiudo gli occhi basito mentre un’arietta mi scapiglia.
Ancora, lui: «Ritornato a casa, troverai qualche lacrima da asciugare…»
Conserto le braccia e piango senza pudore. A testa china.
L’Orèade pettegola: «Da asciugare. Da asciugare».
Resto da solo.
Nel folto della vegetazione qualcosa si muove. Un lungo porticato con volta a crociera si mostra di là da questa.
È illuminato da lampadari a candele. La luce varia intensità mentre con passi sordi, cammino.
Dei mendicanti ai lati degli ingressi laterali aspettano i timorati per tendere la mano. Doccioni. Affreschi che cadono, a brano a brano, assieme all’intonaco. Una dark girl urina dietro ad un pilastro.
Ripetizione. Ripetizione. Ripetizione.
In fondo, una voce aspra e inflessibile che trattiene al guinzaglio un cane rampante:
«Mio gradito ospite, non verrete mai presentato alla signorina. Queste sono le mie disposizioni».
Mi siedo su di un muretto semi-diruto; spenzolo un piede. Rifletto.
Lo guardo in tralice mentre si nutre di una carcassa ancora calda di non so cosa. Ne getta i resti al cane che non si fa pregare per divorarli.
«Volete gradire?» lui a me.
Non gli rispondo. E col rampino bucherello la terra per stornare lo stress.
Scappo. Vago per la selva tenebrosa. I bravacci del padrone mi danno la caccia.
Salgo su di un albero. Mi apposto su di un grosso ramo ad elle. Attendo… Passa un gruppetto di gradassi con a seguire l’atteso.
Lanterne accese per illuminare la via.
Salto sopra al loro capo. Mi rialzo e col rampino gli arpiono il collo fino all’epistrofeo.
Sssssssssss.
Baruffa.
«Uffa. Uffa».
I soggiacenti restano impietriti. Uno di loro fa un passo verso di me ed attacca:
«E poi?»
«E poi è morto,» io.
Visti di schiena. Con le membra intorpidite, tutti, incapaci di scaricare il peso dei loro corpi con dei movimenti di avvio o di perdita.
«Ed ora cosa faremo?» lacrimosi.
Esplode il loggiato.
Non c’è più.
Io (gridando alle faville): «Poveglia è persa!»
«Persa. Persa».
Dall’osservatorio astronomico della Villa, una lei punta lo strumento ottico sull’accaduto… Ci sono. Muove mani inanellate manifestando uno strazio intimo preoccupante. Orbite fonde dalle quali si affacciano bigattini spronati dall’istinto. Disgregazione di proteine. Capelli che cadono. Articolazioni che si distorcono.
Faccio un passo indietro. Mi do coraggio… Nelle private stanze la putrescina si respira ovunque. Altre ossa e toraci scarnificati usati come paralumi. Vene e arterie metallizzate e sbrogliate per passamaneria. Teste con muscoli facciali scollati e nervi oculari penzolanti, allineate sul piano di un cantonale.
Sento di diventare pazzo!
Non c’è vita. Apro con circospezione le ante pesanti degli armadi, in preda al panico. Boa di volpe con un’anima di budello riempito di liquidi corporei.
«Curioso?» la signorina.
Non so che ribattere. Non so dove andare. Non so che pensare.
«Perché tutta questa perversione?!»
«Perché non c’è più un limite».
La stanza si fa sempre più piccola. In preda ai fumi di quale alcol, io? Nello stomaco si rimescolano i succhi gastrici.
«Ho aspettato tanto per conoscerti».
(Futilmente): «Non sono la tua allegoria. Sono una povera di mente: ecco!»
Tenta di uccidermi, ma non ci riesce.
È passato.
Lascio la Valsassina.
«Assassina. Assassina».