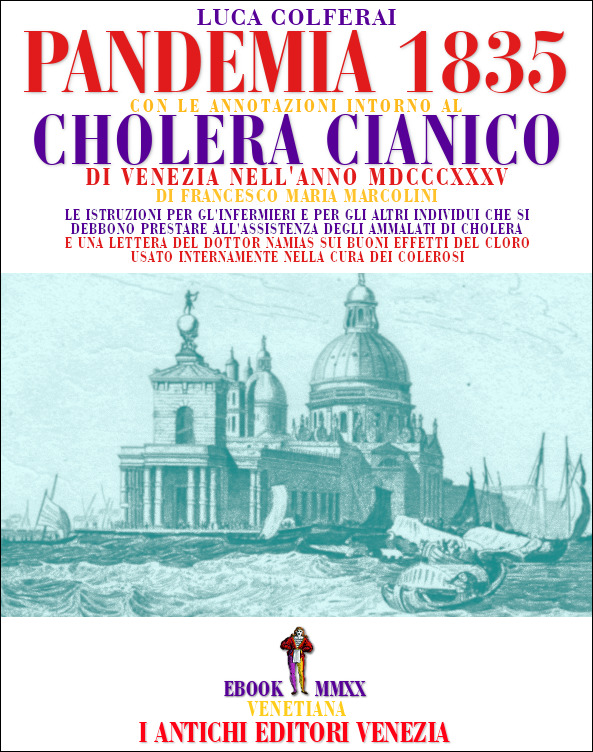La vera storia
di Aquagranda
I retroscena di un debutto trionfale
Undici recite, più di ogni altra opera in cartellone, undici esauriti, una media di quindici minuti di applausi. Questi i numeri imprevisti e sensazionali di Aquagranda, l’opera che per la regia di Damiano Michieletto e le musiche di Filippo Perocco, ha inaugurato in prima assoluta, con grande successo, la stagione lirica 2016-2017 del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Roberto Bianchin, autore del libretto e del libro omonimo da cui l’opera è tratta, racconta in un volume appena uscito, «Fenice Backstage», storia e retroscena di un debutto trionfale.
VENEZIA — Si sentiva il fiato pesante dello scirocco. Proprio come nel giorno dell’alluvione di cinquant’anni fa. Ma era una sera d’estate, e stavamo cenando all’aperto, in campo Sant’Angelo, a Venezia, con alcune persone, non ricordo più quali. Non c’era un motivo particolare, non era una cena di lavoro. Detesto le cene di lavoro. Preferisco andare a cena finito il lavoro e parlare d’altro. Stavamo parlando d’altro. Non ricordo di che cosa. Non ricordo più nulla. Ricordo perfettamente però che tra i commensali c’era il sovrintendente della Fenice, e che a un certo punto, non so perché, non so cosa gli venne in mente, disse che fra tre anni ci sarebbe stato il cinquantenario dell’alluvione, e che gli sarebbe piaciuto, magari, chissà, perché no, ricordarlo con un’opera lirica.
La cosa cadde lì. Nessuno ci fece caso, nessuno commentò. L’idea sembrò non interessare a nessuno. Che stravaganza, del resto. Come si fa a mettere in scena un’alluvione, poi. Difatti per un po’ nessuno ne parlò. Finché un giorno il nome di Cristiano Chiarot, il sovrintendente, apparve sul piccolo schermo del mio Blackberry. “Facciamo l’opera!”, esclamò. “Quale opera?”, risposi. Mi ero già dimenticato delle chiacchiere di quella sera alcolica di scirocco. “Ma come quale opera? La tua!”, sbraitò perforandomi l’unico orecchio funzionante. “Non hai scritto tu un libro che si chiama Aquagranda?”. “Vent’anni fa. E si chiamava Acqua Granda, il romanzo dell’alluvione”. “Aquagranda è più teatrale”.
Le prime riunioni videro insieme al sovrintendente, attorno al suo tavolo, il direttore artistico del teatro Fortunato Ortombina, Damiano Michieletto che il teatro aveva deciso dovesse fare il regista, ed io che ero l’autore. All’inizio si pensò a una doppia inaugurazione, Aquagranda e Attila, con la firma di Michieletto per ambedue le regie. Ma Damiano disse no. Non aveva il tempo di prepararne due. Scelse Aquagranda. Il progetto, disse, lo affascinava, perché lo metteva a contatto con una storia vera e veneziana. Si cominciò dall’analisi del libro, che era un romanzo per modo di dire, perché era scritto come un romanzo ma quello che veniva raccontato non era fiction.
Al contrario. Era tutto vero. Accaduto realmente. Compresi i nomi e le storie dei personaggi, del pescatore Fortunato, del figlio Ernesto che non voleva fare il pescatore, della giovane moglie Lilli e del maresciallo dei carabinieri della stazione di Pellestrina Giovanni Cester che tenne un diario di quelle ore drammatiche. E poi quel libro, dieci anni fa, era già diventato uno spettacolo. Di prosa. Con l’attore Roberto Citran, le musiche dal vivo di Rachele Colombo, la regia di Ketty Grunchi. Aveva debuttato al Malibran di Venezia, aveva girato città e paesi, aveva vinto anche dei premi, e qualche volta in scena c’ero finito anch’io in qualità di narratore. Che poi, in fondo, sarebbe il mio mestiere. E comunque sono decenni che ogni 4 novembre a Venezia declamo l’alluvione -a modo mio- al Circolo de I Antichi.
Decisa che quella era la trama, bisognava fare il libretto dell’opera. “Chi lo fa?”. La domanda cadde nel vuoto. Ci fu un attimo lungo di silenzio attorno al tavolo delle riunioni. Poi fu il sovrintendente a parlare. “Lo fai tu! -disse perentorio fissandomi diritto nel fondo degli occhi con il suo sguardo di falco- hai fatto il libro, farai anche il libretto”. “Non è la stessa cosa –risposi, calmo- il libretto non è un libro piccolo. Io non scrivo libretti d’opera. Per di più non ho nemmeno dimestichezza con l’opera lirica”. “Provaci”, concluse la riunione il gran capo del teatro. Ci provai. Per prima cosa cominciai a studiare libretti d’opera contemporanea. A sviscerarne la tecnica. A carpirne trucchi e segreti. Poi andai a incontrare Daniel Pennac. Sì, proprio lui, lo scrittore. Lui, insieme al compositore Claudio Ambrosini, aveva licenziato di recente il libretto di un’opera moderna che mi era piaciuta molto, “Il killer di parole”.
Cominciai a scrivere rigorosamente a mano come faccio per le cose importanti su fogli grandi di carta grezza color fucsia con la mia vecchia stilografica Montblanc caricata d’inchiostro color seppia. Metà nel mio studio della Bragora, a Venezia, metà in uno studiò di Boulevard Richard Lenoir, a Parigi. Fu un’autentica sofferenza. Durò sei mesi. Giorni serrati di tagli e ritagli, cancellature e riscritture, dubbi e ripensamenti, bestemmie e varemengo. Alla fine, comunque, piacque. Il regista approvò la struttura delle mie dodici scene e partimmo. Più tardi mi verrà affiancato un versificatore di mestiere, Luigi Cerantola, per limare le frasi adattandole alla musica. Restava a questo punto ancora irrisolto il problema di partenza: ma come si fa a mettere in scena un’alluvione?
“Allaghiamo la platea! -propose serissimo il regista durante l’ennesima riunione- in mezzo ci mettiamo una casa che viene lentamente travolta dalle acque, e spostiamo in palcoscenico gli spettatori della platea”. Silenzio. “Allaghiamo tutto il teatro, anche il foyer, e diamo un paio di stivali a tutti gli spettatori che entrano”, aggiunsi in preda a una certa eccitazione. Il direttore artistico cominciava a entusiasmarsi. Io partii destinazione Parma, sopralluogo al teatro Farnese, dove una volta allagavano la gigantesca cavea, una platea di ottantasette (87!) metri di lunghezza, per farne delle spettacolari naumachie. Fummo sconfitti. Le autorità costituite ci fecero capire, anche abbastanza chiaramente, che era meglio se non lo facevamo. Ripiegammo su altre soluzioni.
Alcune decisamente fantasiose, come quella del raggio verde laser che doveva coprire gli spettatori della platea dando l’impressione che fossero immersi nell’acqua fino al collo, come a Gardaland nell’attrazione delle piramidi, o come quella del grande telo di nylon scuro disteso sulla scena, mosso tirandolo ai lati da dietro le quinte con un effetto simile al mare di plastica del Casanova di Fellini. Suggestivo. Alla fine il regista avrà l’illuminazione del muro d’acqua di mille e duecento cinquanta litri che al culmine dell’alluvione piovono ad allagare il palcoscenico per davvero insieme ai suoi protagonisti.
Non avevamo ancora chiarito come sviluppare il racconto. Nel libro c’è una voce narrante che è quella dell’autore che scrive. Ma nell’opera? Iniziammo a pensare di inserire una voce narrante anche nell’opera: un giornalista, un vecchio televisore, un apparecchio radiofonico, un pescatore…No. Non ci convinceva. Alla fine la decisione fu drastica: niente narratore. Banale. Appesantisce. Sa di vecchio. I fatti che sarà necessario raccontare, le notizie che sarà necessario dare, passeranno di bocca in bocca nei dialoghi fra i sette cantanti protagonisti dell’opera. Il coro, monumentale, imponente, da tragedia greca, sarà la voce della laguna che commenterà gli accadimenti, mentre video e vecchie foto dell’epoca scorreranno sul muro d’acqua. Il regista aveva raccolto e filmato voci e testimonianze direttamente sull’isola di Pellestrina, mentre Filippo Perocco, il compositore, aveva raccolto lì i rumori del vento e delle onde, vecchie nenie e canti popolari, il ritmo dei battipali e l’urlo delle sirene delle motonavi.
Strada facendo, si è poi deciso (un altro azzardo!) per l’uso in gran parte dell’opera della lingua veneziana –con l’inflessione e gli accenti degli isolani- anziché dell’italiano. Un veneziano “asciutto”, se non stridesse questo aggettivo con tutta quell’acqua, depurato di ogni retorica, di ogni folclore, di ogni eco goldoniana. Restituito alla purezza, alla sua ancestralità. Voce dell’anima e del cuore. Voce necessaria nelle sciagure come nelle gioie. Rispetto all’impianto originario è stato cambiato anche un personaggio, Luciano il farmacista malinconico ha preso il posto di Don Gino il parroco ubriacone (troppo buffo, fuori sintonia col dramma), e diversamente dal libro Ernesto e Fortunato sono rimasti sull’isola ad aspettare la fine anziché salire sulle navi degli sfollati.
Calata l’acqua, a pericolo scampato, per la festa finale avevo chiesto al compositore una musica gitana, alla Bregovic, e avevo immaginato dei carri navali di dei, uomini e pesci. Perocco ha risposto con una squillante fanfara, Michieletto con un vorticoso girotondo acquatico. Restava il finale. Lieto fine? No. Non c’è lieto fine. Il finale lascia sospesi. Lascia il dubbio. Torna anzi il fosco presagio. Torna l’aquagranda. Torna silente l’onda che lenta affonda. Che sommerge di nuovo i sopravvissuti sul bagnasciuga. Mentre sull’isola scende un’altra volta il buio.
(Tratto dal libro “Fenice Backstage” di Marco Sitran, Heliar Books Edizioni, 2016. Per gentile concessione dell’autore).