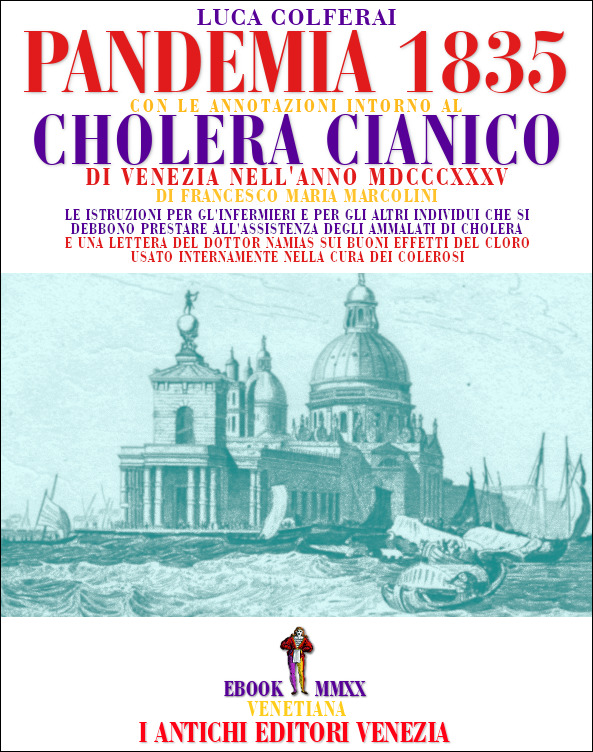La nobiltà
del lavoro
Da anni. Tutti parlano di lavoro. Lavoro che non c’è. Lavoro che nessuno vuole fare. Lavoro che nessuno riesce a fare. Lavoro che è pagato male. Lavoro che dà — dicono alcuni — dignità. Quando c’è e quando è pagato bene, però. Nessuno dice che il problema vero sono i soldi. Di lavoro ce n’è in grandissima quantità dappertutto: sono i soldi che mancano.
Vi ricordate vent’anni fa quando Silvio non era ancora il Papi di nessuno? Vinse le elezioni con un milione di posti lavoro. Promessi. Non è per dargli anche questa croce addosso, è che da vent’anni siamo sempre lì. Questa faccenda del lavoro mi ricorda sempre un’altra cosa.
E molto più gradevole. Il conte Emile Targhetta d’Audriffet de Greoux — cui per motivi che no stago dirve qua sono dedicati questi Venerdì — sosteneva, con un certo orgoglio, di non aver mai lavorato in vita sua.
«Ai bambini — sottolineava con il suo sublime accento aristocratico francese cantilenante di accenti tronchi e erre arrotate in sottofondo — si chiede sempre cosa vorranno fare da grandi: e chi dice il dottore, e chi l’astronauta, un altro vuole fare il pompiere, o anche il postino. Quando ero un bambino io, a me nessuno chiedeva che cosa volessi fare da grande». Non ce n’era bisogno. Anche se nel corso della sua lunghissima vita avrebbe appreso innumerevoli arti: pittura, decorazione, arredamento, sartoria, conversazione; sarebbe stato sempre libero dalla schiavitù del lavoro.
Però. «Una volta, una primavera di molti anni fa — aggiungeva svagatamente pensieroso in un intermezzo delle sue raffinatissime cene con menu ante Rivoluzione (francese, non russa) — acquistai una casa sul lago. Era veramente in rovina, ma mi piaceva moltissimo per la vista deliziosa e per la disposizione delle stanze e anche per l’architettura. La pagai quasi quattromila lire».
Le pause del conte Emile Targhetta d’Audriffet de Greoux erano sempre molto incongrue, anche perché non c’era alcuna fretta di concludere alcunché. Quindi. Mentre Michele serve il vino nei bicchieri di cristallo boemo con stemma nobiliare intagliato alla mola, potete anche azzardarvi a contare quanti anni sono passati da quella primavera basandovi sulla svalutazione monetaria del secolo scorso.
«La sistemai come volevo. Ero giovane per cui non feci alcuna fatica a ridipingere, riattare, risistemare, arredare. Alla fine ne venne fuori una villetta così incantevole che tutti volevano venire in visita e vi diedi anche moltissime feste molto divertenti».
Pausa. «Quando ormai l’estate stava per finire e tutti tornavano in città, un ricco signore inglese mi offrì quarantamila lire se gliela vendevo: “Volete vendermela per questa cifra?” mi chiese prepotentemente. “Non vedo perché no”, gli risposi. E così guadagnai dieci volte tanto quello che avevo pagato qualche mese prima».
Un’altra pausa. Un po’ più lunga della precedente. Potete sorseggiare educatamente la Ribolla gialla, o il Pinot Nero, che avete nel bicchiere mesciuto da Michele. Fissandovi educatamente ma fermamente con i suoi occhi d’azzurro color di lontananza (la citazione è gozzaniana, ma erano proprio di quel colore) il Conte finisce la sua storiella autobiografica con questa frase conclusiva: «Si può proprio dire che quella volta io abbia proprio lavorato». ★