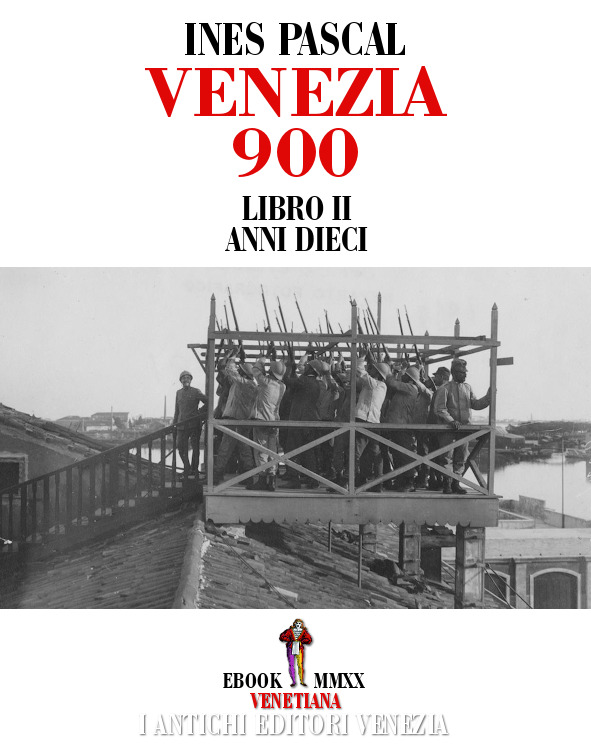Il regime
del naufrago
La terribile gastronomia dei superstiti
La lettura estiva di Storie di naufragi (edito da Odoya), che Laura Mazzolini ha tratto, antologizzando e integrando con nuovo materiale fino ai giorni nostri, dalla mitica opera del settecentesco Louis Deperthes, suggerisce un percorso gastronomico alle sciagure nautiche. Con una lunghissima e doverosa integrazione culinaria, se così si può dire, veneziana.
Il naufragio è una metafora potente, tanto più che è raccontato sempre dai sopravvissuti. Prodotte comunemente dall’errore umano, a volte comprensibile a volte stupefacentemente idiota, le catastrofi nautiche (ma non esclusivamente marine) lasciano un pugno di esseri umani in balia della natura più ostile e indifferente. Feriti, spaesati, soli, ma soprattutto affamati.
Nei secoli scorsi, quando le pignolissime prescrizioni dei sistemisti d’emergenza non avevano ancora pianificato le evenienze, essere vittime di un naufragio significava trovarsi in un gruppo male assortito di quasi compagni di sventura, quasi senza mappe, quasi senza strumenti, quasi senza viveri. La parte peggiore è in quel quasi: non solo insufficienti, ma anche spaiati sbagliati spaesati inadeguati. Una sola bussola, ammaccata; un solo sestante, scardinato; un pacco di gallette, annacquate; un barilotto mezzo vuoto di malvasia di sidro di rum; le mappe le carte erano tutte svolate via.
E poi gli altri superstiti. Per esempio, il 15 aprile 1555, il cannoniere del vascello francese Jacques (naufragato il 26 marzo 1555 nell’Atlantico, di ritorno dal Brasile alla Francia) in mezzo agli altri naufraghi stretti nel relitto della nave decide di asciugare la polvere da sparo dentro un vaso di ferro posto sul fuoco; com’è facilmente prevedibile la polvere da sparo messa al fuoco s’infiamma ed esplode, ustionando orribilmente quattro compagni, di cui uno subito morto; il pilota sbaglia ripetutamente posizione, cosa alquanto facile nelle sue condizioni, e scambia le isole Azzorre per Capo Finisterre in Spagna. «Uno sbaglio così grossolano ci mise in condizioni così disperate da dover recuperare anche le briciole di pane e di biscotto spazzando il magazzino ormai vuoto» scrive il sopravvissuto Jean de Léry, viaggiatore e scrittore francese «vi si trovarono più vermi ed escrementi di ratti che pane ma, nonostante tutto, questi miseri avanzi vennero ripartiti e se ne fece una zuppa più nera e più amara della fuliggine. Coloro che avevano ancora dei pappagalli (parecchi già da tempo avevano mangiato i loro) quando non ci fu davvero più nulla da mangiare, se ne cibarono da maggio in avanti». Ma anche i pappagalli finiscono: «Il 12 maggio morì il nostro cannoniere che io stesso avevo visto divorare le viscere crude d’un pappagallo. […] Dopo aver divorato tutti i cuoi e persino i coperchi dei cofani […] la necessità estrema suggerì di dare la caccia ai ratti […] all’inizio erano molti, ma venivano inseguiti, cacciati e attirati in trappole con così tanti stratagemmi che in breve si ridussero notevolmente. Un topo in quel momento era più prezioso di un manzo a terra; e il suo prezzo arrivò fino a quattro scudi. Venivano bolliti in acqua e mangiati in tutte le loro parti, senza sprecare nulla, neanche le ossa».
Un po’ meglio può andare se si naufraga vicino a una qualsiasi terra emersa. Ma anche là non è facile. Nell’estate del 1596 un vascello olandese alla ricerca di un passaggio settentrionale per le Indie rimase bloccato e scassato tra i ghiacci sulla costa orientale della Nuova Zemlya (a bordo c’era anche Willem Barents, da cui il mare lassù prende appunto nome, come primo ufficiale). Perduti in una natura più che avversa, i naufraghi sono vittime di continui disastrosi incidenti, che affrontano con estrema perizia e determinazione, ma che riducono costantemente il numero dei sopravvissuti. Essendo una spedizione esplorativa non mancano di viveri abilità e riserve. Con il relitto costruiscono una capanna, ma ogni perdita, umana o materiale riduce di molto le possibilità di salvezza: «… vennero caricate diverse botti di birra di Danzica sopra una slitta e trasportate alla capanna, ma proprio in quel momento si levò un così forte burrasca che i marinai lasciarono il carico fuori, sulla slitta. Il giorno successivo trovarono il fondo di una botte rotto dalla violenza del freddo, e la birra talmente gelata che sembrava colla. La botte fu trasportata nella capanna e messa vicino al fuoco; ma la birra invece di riprendere il suo naturale sapore, pareva acqua». Uguale e peggiore sorte per le restanti botti rimaste a bordo: «non fecero eccezione quelle che avevano i cerchi in ferro, alcuni dei quali furono spezzati dal freddo». Ai marinai di Barents non resta che cacciare le volpi «caccia preziosissima perché, oltre alla carne che mangiavamo con bramosia, ci procurò pelli utilissime per fare berrette contro il rigore del freddo»; quando le volpi scompaiono con l’avanzare dell’inverno, si predano sempre più rari uccelli. Il gelo è così intenso che «era ghiacciato tutto, persino il vino di Xeres, quello più alcolico, e per berlo era necessario farlo liquefare prima di distribuirlo in giorni prestabiliti». Essendo pronti a tutto, i naufraghi di Barents festeggiano l’Epifania «anche per distrarci dalle nostre pene»: «con dell’olio e due libbre di farina, tenute da parte per l’occasione, preparammo delle frittelle che gustammo come se fossero state il più ghiotto e delizioso manicaretto del mondo. Questo pranzo venne accompagnato da tutto il vino che avevamo volontariamente risparmiato fino a quel giorno». Oltre al gelo e ai disastri i superstiti si devono guardare anche dagli orsi, temibili abitatori di diritto dei ghiacci, che appaiano all’improvviso incutendo loro un terrore quasi reverenziale difficile da immaginare per noi contemporanei abituati ai documentari dementi della televisione; anche gli orsi vengono mangiati, ma pericolosamente: il 30 maggio 1597 la preda «costò un caro prezzo perché, dopo aver diviso in pezzi la carne dell’animale e fatto cuocere il fegato che era molto saporito, ci ammalammo tutti e tre di noi, per parecchie ore, furono come morti».
La principale preoccupazione dei superstiti salvati, e dei loro soccorritori, è il graduale recupero dell’alimentazione dopo il lungo periodo di privazione, e spesso il confronto con tradizioni culinarie ignote: «ci insegnarono a bere il quas, un liquore russo composto di acqua e pane fermentato che era delizioso, soprattutto dopo essere stati costretti a bere per tanto tempo solo neve sciolta; gli ammalati di scorbuto vennero curati con una specie di prugnola selvatica che cresceva in quelle terre» racconta uno dei dodici sopravvissuti di Barents. Mentre didascalicamente ricorda Jean de Léry: «Ci consigliarono di non mangiare troppo, ci fecero bere poco a poco brodo di gallina, latte di capra e altre pietanze adatte ad allargare lo stomaco senza nuocere. […] Tra quelli che fin dal primo giorno mangiarono senza ritegno, più di dieci su venti morirono subito».
Non tutti i naufraghi se la passano malissimo. Alexander Selkirk, il reale esempio da cui Alexandre Dumas trasse Robison Crusoe saltava come un grillo sull’isola dove l’avevano abbandonato per punizione (l’Isla Juan Fernandes) e si era però ambientato benissimo. Trovatosi nel 1704 dove si erano ambientati prima di lui anche capre, gatti e ovviamente topi, relitti fuggiti o lasciati da altre navi, «la necessità l’aveva abituato alla carne senza sale e senza pane. Durante la bella stagione aveva a disposizione rape deliziose […] cavoli che cucinava con grani di pepe, prodotti dalla pianta del mirto. Queste bacche vengono comunemente chiamate “pepe della Giamaica” e hanno un aroma delizioso. Trovò sull’isola anche una qualità di pepe nero, chiamato malaguita, molto utile per i dolori intestinali e per le coliche». Per difendersi dai topi «pensò di addomesticare i gatti, dando loro bocconcini di carne di capra». Però: «quando [Selkirk] ebbe ripreso l’abitudine alle nostre vivande e ai nostri liquori, sebbene non ne abusasse, perdette molto della forza e della prontezza che aveva sull’isola» anche se gli ci volle molto tempo per riabituarsi: «il nostro cibo era sgradevole per lui e ci volle del tempo prima che potesse apprezzarlo di nuovo».
Disposti a tutto pur di sopravvivere, ogni tanto i naufraghi seguono altresì le loro inclinazioni di gusto. Will il Moskita, che il capitano Watling dimenticò (sul serio) nel 1681 sulla stessa isola di Selkirk vent’anni prima, raccontò che «prima di forgiare gli ami, fu costretto a mangiare carne di vitello di mare, che era un alimento privo di sapore. Quando finalmente poté pescare altri pesci, non uccise più i vitelli marini se non per utilizzarne la pelle come lenze e corregge».
Il cannibalismo tra i superstiti era così diffuso che era dato per scontato e coloro che non vi facevano ricorso ci tenevano tantissimo a sottolineare che se n’erano astenuti. Ma era raro. Il 20 gennaio 1821 i naufraghi dell’Essex (quello da cui Melville trasse Moby Dick) rimasti «con meno di 500 grammi di gallette rimaste, trovarono il coraggio di affrontare un argomento terribile, parlando dell’ipotesi di mangiare il corpo [di un loro compagno appena defunto] invece che seppellirlo in mare». Giorni prima, perduti in una zona di mare senza nulla da pescare, si erano mangiati persino i crostacei e i molluschi cresciuti sull’esterno dello scafo immerso del naviglio, più alcuni pesci volanti precipitati sul ponte. «La situazione continuava a peggiorare – scrisse invece nel 1618 William Isbrantz Bontekoè capitano del De niewe Hoorn per conto della compagnia olandese delle Indie orientali, la cui nave naufragò in seguito ad un subdolo incendio che fece esplodere la santabarbara – I marinai cominciarono a fissarsi gli uni gli altri con un’aria feroce, come se fossero pronti a divorarsi e a cibarsi ciascuno della carne del compagno vicino. Alcuni già parlavano di farlo, cominciando dai mozzi.» Per fortuna avvistarono terra prima di cominciare.
Oltre all’acqua dolce — diceva al suo equipaggio Bontekoè: «Amici non bevete l’acqua salata. Non estinguerà affatto la vostra sete, ma vi farà disidratare e morire» — l’elemento base dell’alimentazione umana della vecchia marineria fu incontrastato il biscotto, detto anche galletta. Un pacco o due di biscotto si salva sempre dalla catastrofe e diviene sostentamento dei naufragi, utile anche per altre evenienze, come racconta ancora Bontekoè: «Si trovava con il chirurgo, ma non aveva medicine con sé. Usò del biscotto masticato per medicare le mie ferite e grazie a Dio questo rimedio mi guarì».
Tutte le marinerie del mondo producevano in proprio il loro biscotto, sotto rigide norme che ne garantivano l’indeperibilità anche nelle condizioni ambientali più estreme. Più simile ad una piastrella in cui una miscela di farina sostituisca l’argilla e la sabbia quarzifera nell’impasto, a Venezia veniva preparato nei forni dell’Arsenale sotto controlli severissimi con una complicata serie di cotture ed era poi distribuito a tutte le unità della flotta militare o venduto alle unità della marina mercantile disposte ad acquistarlo; durava per mesi o anni senza alterarsi.
La galletta a lunghissima conservazione, durissima e poco attraente da secca, si sminuzzava e ammorbidiva con l’aggiunta di acqua, olio, brodo o vino: «è duro come pietra, ma si scioglie una volta immerso nell’acqua o nel vino» scrive il pellegrino domenicano Felix Faber di Ulm imbarcato per la Terrasanta nel 1483. La ricetta era segreta, la preparazione era rigidamente controllata della Camera all’Armar l’organo di supervisione sulla marina militare, la cottura avveniva in forni speciali, trentadue a San Martino, poco distante dall’Arsenale fino al diciassettesimo secolo (scrive il Tassini: «la calle dei Forni a San Giovanni in Bragora prende il nome dai quattrocenteschi Forni militari della Repubblica ivi esistenti dove si fabbricava il pan biscotto per l’armata navale») e poi a Sant’Elena, da fornai tedeschi.
Ancora oggi si trovano pacchi di gallette militari del secolo scorso ancora commestibili; o che almeno non fanno male. Nell’Ottocento parevano una miracolosa eredità del genio della scomparsa repubblica, e le doti di lunga conservazione venivano esaltate con comprensibile nostalgia: frutto di un «singolare magistero adesso ignoto del tutto», come scrive ancora Tassini: «l’anno 1821 si trovò ancora perfettamente sano alquanto biscotto lasciato dai Veneziani in Candia quando nel 1669 cessero quell’isola ai Turchi». Scrive Giuseppe Maffioli in La Cucina Veneziana ( Muzzio, 1982): «Il biscotto era la prima voce nelle liste delle necessità da stivare nelle navi, da inviare ai possedimenti sparsi per il Mediterraneo, da fornire agli eserciti di terra e ai condottieri mercenari al servizio della Serenissima. Nel 1538 il rancio per i marinai e i rematori liberi era stabilito in una minestra, quattro tazze di vino e circa sette etti di biscotto ogni giorno; alla settimana circa mezzo chilo di formaggio, quasi un chilo di carne e quattro sardine; i galeotti non ricevevano biscotto ma fave bollite in acqua. Il biscotto era un surrogato economico e affidabile del pane. La pappa ottenuta sciogliendo il biscotto era detta frisopo, o frisopìn, e il suo uso come alimento era diffusissimo non solo fra militari e marinai ma anche tra i veneziani in città, e non solo tra il popolo». Secondo Giuseppe Boerio (Dizionario del dialetto veneziano, seconda edizione 1856): frisopìn era una «specie di Aggiunto scherzevole o antonomastico, che davasi negli ultimi anni della cessata Repubblica Veneta ai Soldati d’infanteria italiana, per l’uso che essi avevano quand’erano imbarcati, di mangiar la zuppa della macinatura del biscotto». ★
Ricette a base di biscotto
da Giuseppe Maffioli La Cucina Veneziana ( Muzzio, 1982)
Frisopo
Con il «biscotto» prodotto da fornai tedeschi per le navi e per gli eserciti della Serenissima si preparava il frisopo o frisopìn. Oggi, per gli sperimentatori, il biscotto può essere sostituito con i bussolai (salati) o con del pane azzimo.
Frisopin de mar
Ad un trito abbondante di cipolla e aglio si aggiungono acqua, olio e aceto, e si sbriciola il biscotto.
Frisopin de tera
Biscotto sbriciolato nel brodo di carne, usato comunemente dai veneziani del Settecento con il brodo del bollito, piatto allora quotidiano.
Frisopin dei veci
Vino caldo volendo diluito con acqua calda, miele o zucchero, cannella e garofano, biscotto sbriciolato.
Frisopin dei putei
Latte tiepido dolcificato con un po’ di miele, biscotto sbriciolato.
–––––––––-
Louis Deperthes — Laura Mazzolini
Storie di naufragi
ISBN: 978-88-6288-106-7
Pagine: 272 Brossura con bandelle Formato: 15,5x23,5 cm Data di pubblicazione: luglio 2011 Editore: Odoya
http://www.odoya.it/index.php?main_page=product_book_info&products_id=423