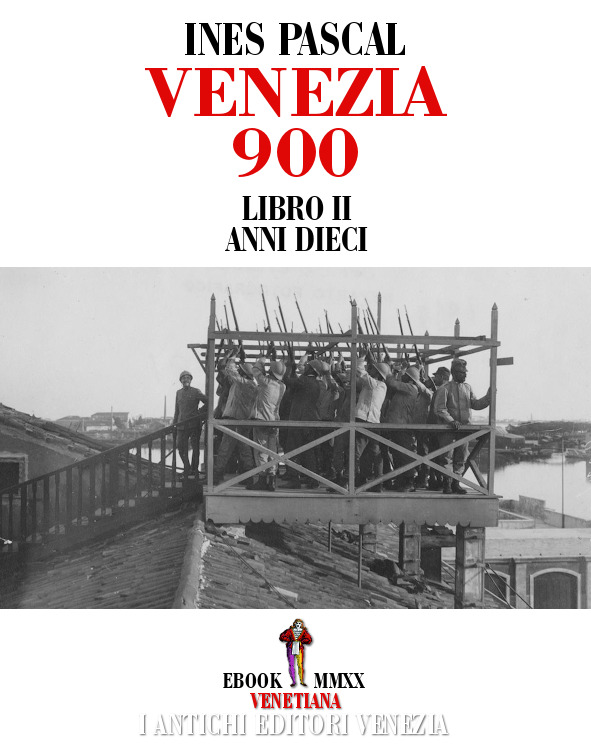Cercando Americanova
e il tesoro nascosto
di un sacco di pannocchie
Storie dei pionieri della bonifica nelle terre strappate alla palude
Il punto di riferimento è la rotonda di Ponte Capitello. Il ponte, piccolo, c’è ancora, forse anche il capitello che gli ha dato il nome. Siamo a nord della provincia di Venezia, fra San Donà di Piave e Caorle, un chilometro a sud del fiume Livenza che lambisce Boccafossa di Torre di Mosto. Qui la storia sembra aver lasciato ben poco, se si eccettua l’epopea della bonifica e pittoresche memorie contadine non solo di guerra.
Questa zona era pur sempre la retrovia del fronte del Piave, che sfocia al Mort, fra Cortellazzo ed Eraclea Mare, neanche dieci chilometri più a sud. Quindi, se la storia sembra avara, stavolta sarà meglio occuparci prima di geografia. Terra di bonifica, un groviglio di canali dai nomi più celebri di quelli delle vie, poiché proprio i canali più o meno navigabili erano le vie di transito prima dell’avvento dell’era dell’asfalto solcato dal copertone di gomma vulcanizzata. Canal Nero, Brian, Fossa, Bocca della Fossa, Sencielli, Cavetta, Taglio, Rotta, Ongaro inferiore, Revedoli. E altri che non esistono più e che hanno dato il loro nome alle strade costruite al loro posto.
Il Ponte Capitello congiunge due canali: la Fossa, che in passato confluiva a nord nel fiume Livenza, e il Sencielli, o Senzielli, che sfociava nel mare a Torre di Fine. Sì, perché nei tempi passati il mare arrivava fin lì. C’è differenza tra canali e fiumi: i canali sono stati scavati dall’uomo per le sue esigenze, i fiumi più o meno andavano per conto loro. Ci sono canali per la navigazione, come la Litoranea veneta, che permetteva di trafficare le merci al riparo dagli assalti dei pirati narentani che scorazzavano in mare aperto. E in seguito, nell’opera di bonifica, canali scavati per esigenze idriche, vale a dire per scolare l’acqua della palude che raccolta nei fossi confluiva – e confluisce tutt’ora – nei canali maggiori e poi, tramite il pompaggio delle idrovore, essere riversata a un livello più alto in altri canali che confluiscono nel Piave o nella Livenza.
Un esempio? L’idrovora di Valle Tagli. O meglio quella monumentale di Torre di Fine, del 1926, la cattedrale sull’acqua a fianco della chiesa di san Ferdinando re (quella con la campane posate per terra, qui niente campanili alti, sprofonderebbero nella melma o si ribalterebbero). L’idrovora di Torre di Fine e annessi è un capolavoro architettonico in mattoni facciavista, decorata di bassorilievi e mascheroni. Al suo interno quattro pompe idrovore (magna acqua) aspirano l’acqua dell’Ongaro inferiore e la vomitano nel Revedoli, che poi la riversa poco distante vicino alla foce del Piave. Osservare, senza avvicinarsi troppo alla voragine d’acqua del canale, il dislivello tra l’Ongaro e il Revedoli: solo così si ha la percezione visiva immediata che qui stiamo sotto il livello del mare. Anche quest’ultimo bloccato da una diga, sul litorale un chilometro più a sud-est, altrimenti si rimangerebbe la terra con camping alberghi e tutto.
Più a nord, a Boccafossa, rimane traccia copiosa del lavoro dei bonificatori, pionieri possidenti terrieri di origine veronese o romagnola. E soprattutto della loro forza lavoro, le braccia dei repetini, i senzaterra che a suon di palottini e carriole scavarono fossi e canali ed eressero argini. Il Museo della Civiltà contadina di Boccafossa, tanto monumentale quando ignorato dalle istituzioni, chiuso proprio in questi giorni dopo che la gigantesca barchessa su tre piani d’inizio Novecento è passata a nuovi proprietari, contiene oltre diecimila fra attrezzi suppellettili macchine che trasudano miseria e fatica. E che di notte rimandano gli echi di grida lamenti invocazioni e sussurri dei fantasmi di mille vite consumate qui, tra le canne palustri e il ghiaccio, tra le zanzare in estate e il pòcio, il fango umido dell’inverno.
Da Boccafossa a Senzielli, fino a Torre di Fine, scorre il canale che il vescovo di Ceneda, ora Vittorio Veneto, aveva comprato dai veneziani come via di traffico verso il mare senza esser costretto a pagar dazio ogni volta. Senzielli è solo un ponte di cemento ammuffito, qualche corte contadina, poche altre casette più recenti. Un piccolo oratorio, un’officina con l’insegna in carattere gotico, la memoria di una trattoria sperduta e difficilmente raggiungibile dove nei fine settimana si radunavano comitive di uomini delle taverne che avevano voglia di far bisboccia oltre l’eccesso. Se ne raccontano di cotte e di crude, compresa l’abitudine, dopo aver abbondantemente bevuto, di gettare i bicchieri da birra direttamente nel canale stando seduti a tavola. Tirandoli fuori della finestra con la finestra chiusa. Ora di quel locale resta solo lo scheletro di una casa senza infissi.
Proseguendo verso monte c’è uno stradone di sassi. Mezzo chilometro più avanti, chiusa dentro il recinto di una villa, c’è la chiesetta di Sette Casoni, stile liberty compito e senza fronzoli inutili (da non confondere con quella più recente sulla provinciale jesolana). Ne parla, e ne disegna, anche Hugo Pratt in un episodio di Corto Maltese, Sotto la bandiera dell’oro. Romanzando a modo suo e ambientando anzitempo nella Grande Guerra una storia quasi vera, quella dell’Oro del Montenegro, il tesoro del re che dopo l’otto settembre del 1943 sarebbe stato paracadutato qui, oltre la linea del Piave, per poi prendere la via della Germania per essere messo al sicuro per tempo in vista della disfatta che sembrava imminente. Una zona ben riconoscibile dal pilota dell’aereo che avrebbe trasportato il carico prezioso, poiché in questa valle vi erano sette bei casoni messi in fila l’uno dopo l’altro. Ora la località si chiama Valcasoni, mentre via Sette Casoni rimane ancora e prosegue fino a Ponte Crepaldo. Dell’oro del Montenegro, nascosto sotto il pavimento della chiesetta, non si seppe più nulla. Anche se tutt’ora gira gente a piedi lungo gli stradoni guardando a terra con in mano un attrezzo simile a un aspirapolvere. Non sono evasi dal manicomio, stanno cercando non-vogliono-dire-cosa col metal detector.
Si favoleggia, qui attorno, anche di alcune grosse botti con all’esterno la scritta chiodi, parcheggiate in zona durante la guerra da un nobile veneziano che tornò a riprendersele qualche anno più tardi, alla fine del conflitto. Curiosità volle che qualcuno le aprisse anzitempo e scoprisse che all’interno tra vestiti di lusso e candelabri dorati vi era ben altro materiale lucente e sonante. Se ne appropriò e lo sostituì con l’equivalente in chiodi. D’altronde all’esterno della botte vi era proprio la scritta chiodi. Leggenda o verità che sia, dopo la guerra qualcuno del posto si ritrovò talmente ricco da poter comprare decine di campi. Fantasia popolare o realtà che sia, tramandata di madre in figlia, nelle osterie si sussurra ancora questa storia. E altre, più o meno documentate, ferite ancora aperte, rigorosamente da non mettere per iscritto, almeno per ora.
Poco più a monte del Ponte Capitello c’è Busatonda. Lì non c’è nulla, tranne il Canal Nero e strane pietre giganti scure che affiorano dai campi e vengono fatte sparire, so dove ma deve rimanere un segreto. Forse i resti di un antico ponte, o di un porto. In effetti a due chilometri da qui c’era, e sta ancora sepolta lì sotto, Civitanova Heraclia, la città romana (sotto il controllo bizantino) fondata dai profughi di Opitergium (Oderzo) in fuga dai Longobardi nelle isole dell’arcipelago di Melidissa. Il reticolo cittadino dell’urbe heracliana è ancora ben visibile nelle foto aeree, sono stati fatti anche degli scavi, viene continuamente rinvenuto materiale che sparisce immediatamente. Se ne parlò anni fa in un libro fotografico curato dai professori Harari e Tozzi. A Civitanova Heraclia fu pianificata l’emigrazione che portò alla fondazione di Venezia; di Civitanova Heraclia la tradizione vuole che fosse originario il primo doge veneziano, Paolo Lucio Anafesto, già esarca di Ravenna o viceversa. Da Civitanova Heraclia partiva un ramo della Via Annia che la congiungeva a Julia Concordia passando per Portus Liquentiae, ribattezzato nel medioevo Torre dei Da Mosto.
E Americanova? Sta qui, col suo paesaggio piatto e il cielo immenso che lascia ammirare nitidamente le Prealpi innevate. Abitata da aironi, garzette e altri volatili lacustri stanziali e migratori, compresi cormorani e colombi di vari tipi che ora si muovono in gruppo per timore di falchi e poiane (c’è anche una cornacchia completamente bianca). Ma, come dicevo all’inizio, questa è più una questione geografica, che storica. I vecchi raccontano che Americanova, terra strappata alla palude nei primo decenni del Novecento, appena roncada, cioè disboscata dalle sterpaglie e poi spianata, apparisse talmente vasta che l’occhio si perdeva all’orizzonte, e coi suoi allevamenti di bestiame e cavalli da traino allo stato semi brado, facesse pensare a una prateria americana. Totalmente assente di vestigia, con poche corti agricole che ospitavano famiglie di decine di persone, solcata da un unico stradone dritto sterrato con pochi sassi, molte pozze e diversi gavìni e fossi che i contadini segavano al terzo (su tre parti di fieno, due al padrone e una se la portavano a casa come compenso).
A suo tempo contava più di mille persone, mentre ora ne sono rimaste poche decine. Aveva, ha tutt’ora, una chiesetta, mentre le scuole sono state prima chiuse e poi demolite. È compresa tra il canale Senzielli e Valle Tagli (quella con la chiesetta tirata su a bestemmie, per ogni bestemmia si doveva offrire in penitenza un mattone per la chiesa, dicono sia venuta su in un lampo), e va a finire a Cavanella di Caorle, altra località semi-sperduta. A nord c’è un altro canale che costeggia la strada verso Brian e Porto Santa Margherita, a sud c’è l’Ongaro inferiore. In Americanova assieme al frumento veniva seminato – anche tutt’ora – il mais, il soturco. Si racconta che per bontà del padrone dopo il raccolto mezzadri affittuali e repetini affamati erano liberi di andare a spigolare, a raccattare le spighe perse e i panocìni, le pannocchie dimenticate, cadute per terra, nascoste dai scartòzzi o semisepolte dal fango. E che d’inverno si potesse liberamente pescare nei fossi.
Ecco qua: nella grande miseria, nella grande fame dei pionieri della bonifica e delle loro famiglie povere e infreddolite del Novecento morto e non ancora sepolto, un pugno di spighe, mezzo sacco di pannocchie sgranate, ammuffite e piene di fango raccolte nella nebbia, qualche misero pescetto intirizzito dal freddo tirato su dal ghiaccio era considerato una fortuna. Altro motivo per ribattezzare questa terra, umida deserta ma fertilissima, col nome del sogno de noantri: Americanova.★